
da Daniele Poto | Mag 4, 2021
 C’è un modo di dire corrivo ma esauriente: ne ha viste più di Carlo in Francia! Trovatemi per analogia un giornalista nostrano che in capo a 65 anni di attività abbia un agenda telefonica (ora su smartphone) ricca come quella di Gianni Minà. Che detiene un altro primato aziendale in Rai: 17 lunghi anni di gavetta senza essere assunto. Amico di Pietro Mennea, di Diego Armando Maradona e del Papa in un filo crosso di connessioni ideologiche note solo a lui che riuscì a intrattenere per tutta una notte Fideò Castro pur di montare un’intervista scoop. Coraggio, empatia e sprezzante disistima del pericolo le qualità innate del cronista da battaglia che, partito da Torino, ha girato il mondo riempiendolo con le proprie passioni sudamericane e con il vivo senso della professione. Liquidato dalla Rai in un amen quando il ventennio berlusconiano gli ha scavato la fossa sotto i piedi. Come possono raccontare anche Luttazzi, Travaglio e Santoro. Ma il meglio era giù venuto, sotto la bandiera di Arbore, di illuminati esperimenti dell’azienda di Stato. Minà era capace di riunire in una notte romana nel più noto ristorante di Trastevere Robert De Niro, Muhammad Alì, Gabriel Garcia Marquez e Sergio Leone. In quella compendiosa foto c’era tutto Minà e il suo potete di fascinazione. Cronista d’assalto, incapace di fare il direttore, come dimostra la sua infelice esperienza a Tuttosport (testata mai nominata nel corso del libro). Le foto parlano più del testo. Un libro nato con una genesi lunga e difficile. Minà oggi over 80 si è avvalso della decisiva complicità di Fabio Stassi che ha registrato queste fluviali confidenze di una vita. A ruota libera, con un copione in divenire spezzettato in tanti capitoli, altrettanti flash di una ininterrotta esperienza professionale. Minà era l’anti-Marzullo, nemico della sedentarietà, delle frasi fatte, inevitabile nemico del potere costituito, in primis quello dell’imperialismo americano.
C’è un modo di dire corrivo ma esauriente: ne ha viste più di Carlo in Francia! Trovatemi per analogia un giornalista nostrano che in capo a 65 anni di attività abbia un agenda telefonica (ora su smartphone) ricca come quella di Gianni Minà. Che detiene un altro primato aziendale in Rai: 17 lunghi anni di gavetta senza essere assunto. Amico di Pietro Mennea, di Diego Armando Maradona e del Papa in un filo crosso di connessioni ideologiche note solo a lui che riuscì a intrattenere per tutta una notte Fideò Castro pur di montare un’intervista scoop. Coraggio, empatia e sprezzante disistima del pericolo le qualità innate del cronista da battaglia che, partito da Torino, ha girato il mondo riempiendolo con le proprie passioni sudamericane e con il vivo senso della professione. Liquidato dalla Rai in un amen quando il ventennio berlusconiano gli ha scavato la fossa sotto i piedi. Come possono raccontare anche Luttazzi, Travaglio e Santoro. Ma il meglio era giù venuto, sotto la bandiera di Arbore, di illuminati esperimenti dell’azienda di Stato. Minà era capace di riunire in una notte romana nel più noto ristorante di Trastevere Robert De Niro, Muhammad Alì, Gabriel Garcia Marquez e Sergio Leone. In quella compendiosa foto c’era tutto Minà e il suo potete di fascinazione. Cronista d’assalto, incapace di fare il direttore, come dimostra la sua infelice esperienza a Tuttosport (testata mai nominata nel corso del libro). Le foto parlano più del testo. Un libro nato con una genesi lunga e difficile. Minà oggi over 80 si è avvalso della decisiva complicità di Fabio Stassi che ha registrato queste fluviali confidenze di una vita. A ruota libera, con un copione in divenire spezzettato in tanti capitoli, altrettanti flash di una ininterrotta esperienza professionale. Minà era l’anti-Marzullo, nemico della sedentarietà, delle frasi fatte, inevitabile nemico del potere costituito, in primis quello dell’imperialismo americano.
data di pubblicazione:04/05/2021
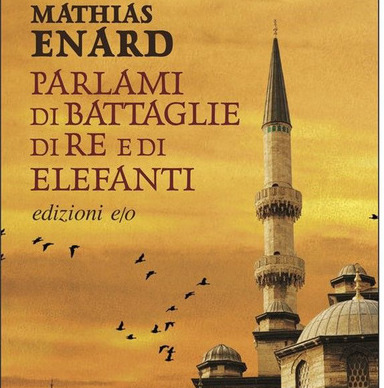
da Antonio Jacolina | Mag 3, 2021
 Torna in libreria in una nuova edizione riproposta, questa volta, da E/O, il breve racconto di Mathias Enard che era già stato pubblicato nel 2013 per i tipi Rizzoli. Avevamo avuto l’opportunità di leggerlo in francese già nel 2010 quando era appena uscito ed aveva vinto il Premio Goncourt dei Liceali. L’autore in questi 10 anni si è affermato poi come uno dei più significativi scrittori francesi ed ha vinto il massimo premio letterario: il prestigioso Goncourt nel 2015 con La Bussola.
Torna in libreria in una nuova edizione riproposta, questa volta, da E/O, il breve racconto di Mathias Enard che era già stato pubblicato nel 2013 per i tipi Rizzoli. Avevamo avuto l’opportunità di leggerlo in francese già nel 2010 quando era appena uscito ed aveva vinto il Premio Goncourt dei Liceali. L’autore in questi 10 anni si è affermato poi come uno dei più significativi scrittori francesi ed ha vinto il massimo premio letterario: il prestigioso Goncourt nel 2015 con La Bussola.
Già il titolo del racconto è magnifico di per se stesso! Un titolo poetico che è come un’invocazione, una richiesta di poter ascoltare una bella storia affascinante che unisca mito e realtà e che finisca col trascendere fra il vero, il verosimile e l’auspicabile e che faccia sognare fra finzione e ricostruzione storica. Questo breve ma intenso romanzo è proprio il racconto del possibile incontro di Michelangelo, Uomo del Rinascimento ed Artista con la magia e la bellezza ambigua del mondo orientale. Enard si impadronisce infatti con talento di alcune settimane della vita del Buonarroti dimenticate dalla Storia, e … sulla base di un dettaglio, inventa una storia affascinante.
13 Maggio 1506, Michelangelo sbarca a Costantinopoli conquistata dai Turchi poco più di cinquanta anni prima, nel 1453. Nonostante il divieto di Papa Giulio II, ha lasciato di nascosto Roma perché irritato per il mancato riconoscimento dei giusti compensi per le sue prestazioni artistiche. E’ passato per Firenze, e … lì ha accettato l’invito del Gran Sultano di recarsi a progettare un ponte sul Corno D’Oro, progetto su cui aveva già lavorato Leonardo da Vinci ma che era stato giudicato inidoneo dal Sultano stesso. Costantinopoli, pur in mano Turca, è tornata ad essere una delle più grandi città dell’epoca. Ancora fortemente impregnata di cultura greca e latina ha un aspetto cosmopolita a cavallo fra Occidente ed Oriente, fra mondi, culture e religioni diverse ed è luogo di grandi commerci e ricchezze. Una città sensuale e carnale le cui atmosfere l’autore rende a meraviglia così come ci disegna anche un ritratto toccante dell’artista in preda dei suoi dubbi, delle sue curiosità e della sua passione creativa. Un uomo quello disegnato da Enard che, al di là delle sue ambizioni artistiche, si lascia incantare e turbare dal fascino ambiguo della città di cui scopre monumenti e taverne, inebriandosi di bellezza, di versi e di danze sensuali. Costantinopoli vibra e respira come viva sotto la penna dello scrittore, un mondo spaesante ma pieno di poesia e profumato di mille sentori di voluttuosità esotica e di scoperta dell’altro da sé. L’autore porta così i lettori in un racconto sempre più affascinante come fascinante poteva ancora essere ed apparire Costantinopoli agli occhi di un occidentale. Michelangelo si perderà ammaliato piano, piano in questa città. Una storia di desideri, di dubbi e di tormenti alla ricerca dell’estasi creativa, dell’amore e del bello.
Una scrittura piacevole e fluida quella di Enard, precisa e ricca di immagini. Un racconto cesellato come un pezzo di oreficeria, a tratti cupo ed a tratti luminoso, impregnato di mistero. Un testo breve ma dalla forza poetica incredibile, ove le parole, al di là di alcuni eccessivi simbolismi, trovano sempre il loro giusto posto per dare musicalità a tutto il racconto. Un piccolo libricino piacevole a leggersi che lascia il lettore in un’atmosfera indefinita ed ovattata, con un leggero senso di incompiutezza perché avremmo voluto tutti restare in queste atmosfere ancora un po’ più a lungo.
data di pubblicazione:03/05/2021

da Daniele Poto | Mag 3, 2021
 Non inganni il titolo di un libro che può avere difetti di ripetitività ma certo non annoia. Paolo Nori è illustre e spiritoso traduttore dal russo e il riferimento ai matti sottintende ammirazione per un popolo e una letteratura fuori dalle consuete rotte continentali e che in Italia si sofferma sui classici ma trascura quanto di vitale è stato trasmesso dalle generazioni del dopo Solgenitsin. Il testo si presenta con un sottotitolo da antologia (Corso sintetico di letteratura russa 1820-1991) ma in realtà è un bizzarro susseguirsi di liberi interventi su autori celeberrimi con Gogol, Tolstoi, Goncarov. Dunque quasi un’opera didattica ma condita dal marchio dell’eccentricità oltre che della competenza. Nori è consapevole di svolgere opera provocatoria ma al fianco dei famosi introduce figure decisamente meno note come Erofeev, la cui psichedelica romanzesca si sviluppava sotto gli effetti della vodka, la droga dei poveri o Slovskyij, uno dei padri dello strutturalismo con la rappresentazione della sua interessante teoria per cui la letteratura è un misto di straniamento della realtà e di complicazione della forma, considerati in combinazione binaria la ricetta perfetta del romanzo. Si può fare divulgazione intelligente e stimolante e questo libro né è un preclaro esempio. Due arricchimenti aggiungono fascino alla proposta. Nella parte centrale con la suggestione del bianco e nero campeggiano fotografie storiche dei grandi della letteratura storica: ampie barbe, maestosità, amicizie intrecciate. E il volume si conclude con una sorta di ricognizione sugli accenti giusti con cui declinare i cognome dei componenti del Gotha, suggerimento a uso e costume dei meno provveduti in fatto di lingue dell’est. Le riflessioni sull’arte e sulla professione di scrittore evadono pretestuosa mente dal confine russo anche se il timbro di personaggi come Oblomov o Raskolnikov strega un lettore disposti a farsi rapire dal mood russo/sovietico. Qui scopriremo cosa sia il samizdat e anche perché molti dei grandi hanno trovato fortuna e riconoscimento all’estero.
Non inganni il titolo di un libro che può avere difetti di ripetitività ma certo non annoia. Paolo Nori è illustre e spiritoso traduttore dal russo e il riferimento ai matti sottintende ammirazione per un popolo e una letteratura fuori dalle consuete rotte continentali e che in Italia si sofferma sui classici ma trascura quanto di vitale è stato trasmesso dalle generazioni del dopo Solgenitsin. Il testo si presenta con un sottotitolo da antologia (Corso sintetico di letteratura russa 1820-1991) ma in realtà è un bizzarro susseguirsi di liberi interventi su autori celeberrimi con Gogol, Tolstoi, Goncarov. Dunque quasi un’opera didattica ma condita dal marchio dell’eccentricità oltre che della competenza. Nori è consapevole di svolgere opera provocatoria ma al fianco dei famosi introduce figure decisamente meno note come Erofeev, la cui psichedelica romanzesca si sviluppava sotto gli effetti della vodka, la droga dei poveri o Slovskyij, uno dei padri dello strutturalismo con la rappresentazione della sua interessante teoria per cui la letteratura è un misto di straniamento della realtà e di complicazione della forma, considerati in combinazione binaria la ricetta perfetta del romanzo. Si può fare divulgazione intelligente e stimolante e questo libro né è un preclaro esempio. Due arricchimenti aggiungono fascino alla proposta. Nella parte centrale con la suggestione del bianco e nero campeggiano fotografie storiche dei grandi della letteratura storica: ampie barbe, maestosità, amicizie intrecciate. E il volume si conclude con una sorta di ricognizione sugli accenti giusti con cui declinare i cognome dei componenti del Gotha, suggerimento a uso e costume dei meno provveduti in fatto di lingue dell’est. Le riflessioni sull’arte e sulla professione di scrittore evadono pretestuosa mente dal confine russo anche se il timbro di personaggi come Oblomov o Raskolnikov strega un lettore disposti a farsi rapire dal mood russo/sovietico. Qui scopriremo cosa sia il samizdat e anche perché molti dei grandi hanno trovato fortuna e riconoscimento all’estero.
data di pubblicazione:03/05/2021

da Antonio Jacolina | Mag 3, 2021
Due donne mature, Nina (Barbara Sukowa) e Madeleine (Martine Chevallier) hanno nascosto a tutti il profondo, delicato e vivo amore che le lega da anni e vivono felicemente la loro storia in due appartamenti contigui sullo stesso pianerottolo. Agli occhi di tutti, compresi i figli adulti di Madeleine, sono solo due amiche, vicine di casa. Un drammatico imprevisto sconvolge però gli equilibri ed i non detti….
La bellezza ed il senso stesso dei Festival e di eventi come la Festa del Cinema di Roma, sono talora le occasioni per gli appassionati del Buon Cinema di scoprire dei piccoli gioielli. Esce finalmente, nelle poche sale che hanno riaperto, quella che era stata una felice scoperta nel 2019 e che finora non aveva avuto occasioni di programmazione (la dice lunga sulla nostra distribuzione!!).
Una scoperta resa ancor più bella perché imprevista in quanto si tratta di un’opera prima di un giovane regista. Il gioiellino è Deux ed il regista è Filippo Meneghetti, italiano di nascita ma che vive e lavora in Francia ove, finora, si era distinto solo come autore di cortometraggi. La Francia, giustamente, lo ha già prescelto per concorrere come “miglior film straniero” agli Oscar del prossimo anno. Ne ha tutti i titoli, anche se ovviamente è troppo presto per far previsioni.
Deux è il debutto di Meneghetti come regista e come cosceneggiatore. E che debutto! Un nome il suo da tenere ben in evidenza per il futuro, perché il suo piccolo film è bello, delicato, ottimamente sceneggiato, finemente interpretato ed abilmente diretto mostrando stile, talento ed eleganza.
Al cuore dell’opera è l’Amore e l’Universalità del sentimento, la sua forza, il desiderio, la tenerezza che tutto superano e tutto travolgono. Che poi la storia si centri sulla relazione fra due donne nulla cambia ai valori espressivi, anzi la rende solo più innovativa, viva, tenera ed originale.
L’abilità dell’autore è proprio nel saper accompagnare lo spettatore lungo la vicenda senza mai scadere nel facile bozzettismo, nei clichè o nel patetismo. Il dramma poteva scivolare nel melodramma, invece il Meneghetti sa mantenere ben saldo il film nella realtà facendoci vivere tutta una gamma di emozioni e sentimenti reali: ora divertente, ora bello, ora malinconico, ora dolce-amaro, ma mai triste o disperato, senza alcuna scena superflua, aiutato in questo da una sceneggiatura essenziale ed intelligente, con un ritmo narrativo teso e vivace ottimamente costruito. Coadiuvano il regista un cast di attori perfetti nei secondi ruoli e poi, soprattutto e sopra tutti, ci sono loro, le due ottime protagoniste, una più brava ed intensa dell’altra. Il film, in effetti, è tutto loro dalle prime inquadrature fino alla dolce, poetica e tenera scena finale. Superbe e penetranti entrambe nel gioco recitativo fatto di soli sguardi ed emozioni e sentimenti legati tutti al filo di un amore e di un dolore tanto pudichi quanto commoventi per la loro ammirevole forza.
Siamo lontani dal pur garbato americano Carol (2015), ed anni luce dal francese Vita di Adele (2013) o da un racconto sul perbenismo di facciata della “provincia profonda” francese con atmosfere alla Chabrol che l’ambientazione potrebbe richiamare. Siamo invece in un film in cui luoghi e circostanze sono solo lo spunto per un racconto d’amore dolce, senza età, poetico e tenero ma mai sdolcinato. Tutt’altro!
Andate a vederlo, Deux è una splendida storia d’amore tanto tenera e poetica quanto altresì complessa; proprio come tenera , complessa e misteriosa è la Vita e con lei anche l’Amore. Sempre! Un piccolo bel film senza pretese che catturerà tutti gli spettatori sensibili. Ad averne di piccoli film così!
data di pubblicazione:03/05/2021
Scopri con un click il nostro voto: 

da Maria Letizia Panerai | Apr 29, 2021
“Mia madre dice che lei è una senza tetto, è vero? No, non sono una senza tetto, sono senza casa. Non è la stessa cosa…”. Fern, dopo la morte del marito minatore e lo svuotamento di Empire, la piccola cittadina mineraria dove vivevano, decide di vendere tutto e di condurre una vita da nomade attraverso l’America, a bordo del suo van che ha personalizzato come fosse una casa. Il viaggio le servirà per capire che i ricordi non si coltivano solo restando nei posti dove si è stati felici, o circondandosi degli oggetti di una vita ai quali sovente siamo morbosamente attaccati, ma si possono “ritrovare” altrove, soprattutto nelle persone che si incontrano lungo il proprio cammino.
Complice la riapertura delle sale cinematografiche, Nomadland rappresenta a tutto tondo il film per “ricominciare a vivere”, un’esortazione a farlo in modo non convenzionale, a contatto con la natura, in maniera semplice, senza necessariamente ricorrere ai dettami della società tradizionale. La pellicola è un vero e proprio inno alla vita, seppur intrisa di momenti di profonda drammaticità: mai come oggi il suo messaggio è roboante, dopo che un virus è bastato a far crollare i sistemi del mondo intero.
Chloé Zhao, Oscar 2021 per la miglior regia e per il miglior film, già Leone d’oro 2020, sceneggiatrice, montatrice e coproduttrice del film assieme a Frances McDormand, ha soli 39 anni ed è una donna, cinese, che ha saputo dirigere una storia molto “americana”, ma universalmente comprensibile, che parla della ricerca della propria indipendenza. Fern, ruolo che è valso l’Oscar come miglior attrice a Frances McDormand, ri-trova il senso della vita abbandonando la casa, dove aveva vissuto una vita felice con il marito, e spostandosi da un posto ad un altro senza paura della solitudine, facendo lavori spesso stagionali e partecipando, inizialmente con diffidenza, ai raduni tra nomadi, persone che hanno perso tutto e che non sempre hanno scelto di vivere così. Nelle loro storie Fern scopre tanta umanità, tanta sofferenza e tanta voglia di ricominciare, ma anche tanto coraggio nel non farsi sopraffare dal dolore e dalla paura. Lei ha scelto di avere al posto di una casa il tetto del suo furgone sulla testa e sente che la sua vita può continuare anche da lì.
Nomadland non è la solita storia di rinascita attraverso un viaggio on the road, è molto di più, perché si sforza di dare il giusto peso ad ogni cosa, ad ogni gesto, con uno stile asciutto senza retorica e senza lacrime, ma con realismo, con un profondo, sano, realismo. “Una delle cose che amo di più di questa vita è che non c’è un addio definitivo. Ho conosciuto centinaia di persone qui, ed io non dico mai addio per sempre, dico solo: ci vediamo lungo la strada…”. Dobbiamo dunque continuare a viaggiare, perché la vita è movimento, in un mix perfetto di socialità e solitudine.
data di pubblicazione:29/04/2021
Scopri con un click il nostro voto: 

da Antonio Jacolina | Apr 26, 2021
Anno di crisi del Cinema e delle sale cinematografiche 2020/21! Anno di mestizia e di illusioni! …
Quella che sembrava dover essere solo la consacrazione ufficiale dello strapotere produttivo/realizzativo e distributivo di Netflix negli anni della Pandemia con la più che attesa vittoria del “suo” pluricandidato Mank (ben 10 nomination, in buona parte meritate perché resta comunque un bel film), è risultata invece … una “prevista sorpresa” a conferma che il Cinema è ancora vivo e che Hollywood e gli Oscar sono sempre imprevedibilmente prevedibili e che gli “americani” ragionano sempre in modo diverso da noi “europei” (il che non vuol assolutamente dire che poi ragionino sempre male!). La “prevista sorpresa” è proprio la più scontata possibile buona alternativa …
Vince infatti gli Oscar per il Miglior Film, la Migliore Regia e la Migliore Attrice Protagonista proprio il film che aveva già vinto a Venezia, a Toronto ed era già stato premiato con i Golden Globes! Parliamo ovviamente di Nomadland di Chloé Zhao con Frances McDormand.
Un film da vedere assolutamente in sala e sul grande schermo, un film che, quasi sulle orme di Furore di Steinbeckiana e Fordiana memoria, ripropone, ovviamente con tempi, ritmi, modi, panorami e segni diversi, il tema molto americano delle migrazioni interne lungo le strade dell’America Profonda di un variegato e non sempre dolente popolo di bisognosi alla ricerca di occasioni di lavoro. Bisognosi ma pur sempre gelosi della propria libertà! Uno dei miti fondanti degli Stati Uniti e del suo Cinema. Un film voluto, amato e magnificamente interpretato dalla bravissima (chi può più provare a negarlo?) Frances McDormand che ha così fatto tris dopo i riconoscimenti per Fargo e per Tre manifesti a Ebbing, Missouri raggiungendo nell’Empireo delle tre volte premiate: Ingrid Bergman e Meryl Streep ed ha davanti a sé anche tutto il tempo per raggiungere Katharine Hepburn con le sue 4 statuette. Un film coinvolgente, lirico ed al contempo fortemente impegnato sul piano sociale, un film corale perché attorno e con la McDormand recitano e vivono i veri protagonisti di questa nuova “terra di nomadi”.
Altrettanto meritatissimo non poteva che essere l’Oscar per il Migliore Attore Protagonista andato ad Anthony Hopkins per The father, adattamento di una piéce teatrale già portata sullo schermo nel 2015 dal francese Philippe Le Guay in “Florida” con l’indimenticabile Jean Rochefort. Storia tenera e drammatica di un processo inarrestabile di demenza senile che di avvisaglia in avvisaglia incide sul rapporto fra un padre ed una figlia.
L’attesissimo Judas and the black Messiah che in anni di dominante politically correct e di attenzione alle minoranze sembrava essere predestinato a grandi trionfi, si è dovuto accontentare degli Oscar per il Migliore Attore Non Protagonista e per la Migliore Canzone. Grande delusione poi, ancora una volta, per le attese della pur brava e meritevole Glenn Close cui è stata preferita come Migliore Attrice Non Protagonista la coreana Yoon Yeo-jeong nel ruolo della nonna nel film Minari già apprezzato al Sundance Film Festival e dai Golden Globe. Per concludere con i “grandi premi”, l’Oscar per il Miglior Film Straniero è andato infine ad Another Round del danese Thomas Vintenberg .
L’Italia, il Cinema italiano, al di là delle tante chiacchiere e delle facili montature ed esaltazioni giornalistiche, non aveva candidature di rilievo o in aree significative, nulla vince nemmeno nelle due uniche piccole nomination marginali. Abbiamo forse bisogno di ulteriori conferme del processo di crescente marginalizzazione del nostro cinema? Abbiamo motivo di ripetere ed elencare ancora una volta le tante cause della nostra crisi? Direi proprio di no!
Dunque, Oscar insoliti e forse un po’ sottotono, ma sappiamo che buona parte dei film proposti hanno avuto scarsa circolazione fra il pubblico e poi … che i veri big non sono usciti affatto!!
data di pubblicazione:26/04/2021

da Antonio Jacolina | Apr 26, 2021
 ”… Poco più di 40 anni fa, di questi giorni, il 29 Aprile 1980, moriva uno dei massimi autori della storia del Cinema, Alfred Hitchcock colui che ha saputo coniugare quello che usualmente si chiama Cinema d’Autore con il successo commerciale, la ricerca e la sperimentazione stilistica con la riconoscibilità rassicurante del cinema di genere, l’angoscia con l’umorismo …”.
”… Poco più di 40 anni fa, di questi giorni, il 29 Aprile 1980, moriva uno dei massimi autori della storia del Cinema, Alfred Hitchcock colui che ha saputo coniugare quello che usualmente si chiama Cinema d’Autore con il successo commerciale, la ricerca e la sperimentazione stilistica con la riconoscibilità rassicurante del cinema di genere, l’angoscia con l’umorismo …”.
L’uomo è morto, ma non certo l’Autore perché i suoi film non hanno mai smesso di circolare e di appassionare nuove generazioni di spettatori, sfidando l’usura del tempo ed il cambiamento dei gusti. Hitchcock era e resta tutt’ora il cineasta più accessibile a tutti i tipi di pubblico per la chiarezza, la cura, la semplicità del suo lavoro, ma, al tempo stesso, era e resta l’Autore tra i migliori capace di entrare nella psicologia dei suoi personaggi e, soprattutto, capace di creare un nuovo tipo di protagoniste femminili dalla personalità affascinante e complessa. Donne giovani, eleganti e belle: di una bellezza algida e senza tempo. Tutte bionde! (“bionde dentro” diceva lo stesso Hitchcock), esteriormente fredde e tutte soggetto di identificazione dello spettatore piuttosto che oggetto di desiderio! Un ideale femminile di gran fascino e carisma in cui però l’enigmaticità prevale sempre sul sex appeal.
Eppure è solo dopo la sua morte e dopo l’uscita nel 1985 (nella versione definitiva) della splendida intervista che Truffaut gli aveva fatto nel 1962, è solo allora, sull’onda del punto di vista degli autori della Nouvelle Vague, che il giudizio e lo sguardo della Critica e degli studiosi di cinema cambia definitivamente e si scopre ovunque il grande Genio ed il grande Maestro. “… un artista del brivido che ci ha fatto condividere le proprie ossessioni, aiutandoci così a meglio conoscerci, cosa che costituisce il fine fondamentale di qualsiasi opera d’arte …” scriveva Truffaut.
Solo che … mentre Truffaut amava le donne, Hitchcock forse non ha mai cessato di averne paura !!
Dalla tanto imitata e mai eguagliata intervista di Truffaut è passato tempo ed infiniti sono stati i saggi sul nostro regista, eppure il libro di Tronnolone è un piccolo gioiello tanto per i cinefili quanto per i semplici curiosi. E’ evidente la fascinazione e l’ammirazione dell’autore verso il regista ed anche la profonda conoscenza della sua vita e dei suoi lavori. Un libro scritto con prosa chiara e coinvolgente e con un tocco di humour in cui ci si diverte a leggere i retroscena della nascita di alcuni capolavori, le vicende del casting, i rapporti di Hitchcock con gli attori e soprattutto con le “sue” attrici: le “sue” muse ispiratrici che amava come solo un Pigmalione può amare ciò che ha faticato a plasmare. Seguiamo così in 24 capitoli dedicati ad altrettanti film ed alle figure prevalentemente femminili che compongono l’universo del regista, l’evoluzione del lavoro di Hitchcock e l’evoluzione del rapporto dell’uomo e dell’autore con le “sue” donne, le bionde glaciali, le loro scoperte e perdite, ed in parallelo anche l’evoluzione del Cinema, i progressi tecnici, le innovazione nelle riprese, il suo “metodo” di dirigere gli attori, la capacità di creare la suspense, l’elaborazione delle splendide sceneggiature, i trucchi. Il tutto in modo divertente, con dovizia di aneddoti saporosi, riflessioni e notizie una più gustosa dell’altra, ed in modo appassionante grazie proprio alla passione ed alla competenza che irradia tutta l’opera fino alla fine.
Al termine non ci resta che un solo desiderio: tornare a rivedere alcuni film avendo in testa i nuovi fatti che li riguardano. Un piacere nuovo ed ancora più sottile, una consapevolezza che ci consente di leggere, notare e godere in modo diverso i film e, più in particolare, il senso della scelta del cast femminile, la ricerca della donna ideale, dell’attrice ideale, e di comprendere il trauma della perdita di questa donna/attrice … Ingrid Bergman … Un sogno trovato e perduto !!…
Un libro originale ed accattivante, godibilissimo e da gustare.
data di pubblicazione:26/04/2021

da Giovanni M. Ripoli | Apr 26, 2021
Libera accattivante esemplificazione della vita di Leonardo da Vinci in una serie TV di produzione internazionale destinata al grande pubblico. Ha debuttato il 23 marzo su Rai 1
Ai tanti che a torto o a ragione hanno storto la bocca di fronte alla serie incentrata sulla vita e le opere del grande artista accusandola di poca fedeltà storica, rispondo da umile scriba che di “fiction” trattasi/ trattavasi e come tale va/andava/ fruita.
Dalla scelta del fascinoso protagonista, l’attore irlandese Aidan Turner, un Leonardo ambizioso e permalosetto, alla comprimaria Caterina da Cremona resa credibile da Matilda De Angelis, in un personaggio che quasi certamente non è stato rilevante nella reale vicenda umana di Leonardo ( era, forse, solo una delle tante cortigiane del periodo), dalla trama romanzata alle attente scenografie, tutto è costruito per offrire un godibile spettacolo in tempi di pandemia a un pubblico internazionale. Naturalmente, a onore degli ideatori, Frank Spotnitz e Steve Thompson, va detto che non tutto è inventato, ma non era certo nelle intenzioni degli autori, seguire fedelmente le fonti storiche più accreditate limitandosi ad una rappresentazione del tempo e dei personaggi più noti incontrati da Leonardo nella sua vita. I meno giovani ricorderanno uno sceneggiato del ’71. La Vita di Leonardo da Vinci interpretato da Philippe Leroy nel doppio ruolo di Leonardo giovane e vecchio, ma l’ultimo “Leonardo” da ricordare era quello vestito da Paolo Bonacelli nel dissacrante e divertente, Non ci Resta che Piangere. Se confrontato poi con, Il Codice da Vinci, completamente privo di ogni verità storica, questo Leonardo, ripeto, seppure con molta fantasia e omaggi allo stile seriale ha alcune frecce al suo arco e si fa seguire con interesse. L’aria che si respira è la stessa dei, Medici( non a caso la stessa produzione Lux Vide più Rai), dietro ci sono 1900 ore di lavorazione, 3000 comparse, 2500 costumi, un significativo cast di attori italiani e stranieri, fra cui Giancarlo Giannini (Andrea del Verrocchio), Freddie Highmore (Stefano Giraldi) e i già citati protagonisti Aidan Turner e Matilda De Angelis, sempre più avviata ad una folgorante carriera da star internazionale. Sia Firenze che Milano sono state fedelmente ricostruite in studio ma appaiono credibili come suggestive sono le rappresentazioni dei momenti creativi e delle opere del genio del Rinascimento. Aggiungete una regia mai eccessiva (Dan Percival ex documentarista della BBC, pluri premiato), una trama “gialla” col nostro accusato ingiustamente di omicidio, qualche accenno alle sue perplessità sessuali, l’esistenza di un pargolo di dubbia paternità ed ecco che la miscela è perfettamente resa anche in vista di una seconda inevitabile stagione. Se della trama poco vi ho detto è per non togliervi il gusto di sintonizzarVi su Rai play per seguire tutti gli episodi. Per le verità storiche vi rimando a una biografia dello storico Charles Nicholl. Giudizio finale: potabile!
data di pubblicazione:26/04/2021

da Daniele Poto | Apr 24, 2021
 Il palese riferimento è al mondo dello spettacolo: fermo anzi immobile. Però meglio dal vivo che dal morto, cioè in streaming, con una finzione di immedesimazione in assenza di pubblico. Paolo Rossi, comico ammaccato di mille vizi, ex alcolista non anonimo, si rivolge a un colloquio immaginario con William Shakespeare per riflettere sulla strana situazione umana del fermo biologico in periodi di pandemia. Esperienze di una vita e di una creatività non soffocata ora che alcuni dei migliori amici (Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Felice Andreasi) non ci sono più. Sono irresistibili le pagine di descrizione del nascente cabaret milanese del derby, posto di gestazione ma anche locale equivoco che per mantenersi in vita obbediva a un’etica tutta sua, borderline rispetto alla legge, al consumo di droga e di ulteriori infrazioni legali. Da perfetta stand up comedy l’invocazione a Berlinguer che dall’oltretomba gli si affaccia in sogno per chiedergli che fine ha fatto il Pci. Un sogno all’incontrario nelle risposte che Paolo Rossi gli fornisce descrivendo un quadro idilliaco che è l’esatto stravolgimento della realtà attuale. Graffiante, malinconico, lisergico, Rossi ha sprazzi sulfurei che sono il giusto antidoto alla banalità del reale. Dal gin tonic in quantità siderale alle riflessioni argute sulla sparizione delle Feste dell’Unità, la descrizione di un mondo di sinistra evaporato nelle brume del capitalismo, del teatro come merce, del posto fisso degli Stabili. Comicità da alto e basso, biografica e non di un guitto che molto ha dato anche alla televisione vivendo in contraltare satirico gli anni d’oro di Berlusconi, bersaglio ormai non più attivo e valido. C’è molta vita, dalla nascita alla vecchia nel segno di una parabola che non vuole finire e si riproduce anche con il tramite della mimesi letteraria. Si può scrivere infine che Paolo Rossi è vivo e satireggia insieme a noi.
Il palese riferimento è al mondo dello spettacolo: fermo anzi immobile. Però meglio dal vivo che dal morto, cioè in streaming, con una finzione di immedesimazione in assenza di pubblico. Paolo Rossi, comico ammaccato di mille vizi, ex alcolista non anonimo, si rivolge a un colloquio immaginario con William Shakespeare per riflettere sulla strana situazione umana del fermo biologico in periodi di pandemia. Esperienze di una vita e di una creatività non soffocata ora che alcuni dei migliori amici (Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Felice Andreasi) non ci sono più. Sono irresistibili le pagine di descrizione del nascente cabaret milanese del derby, posto di gestazione ma anche locale equivoco che per mantenersi in vita obbediva a un’etica tutta sua, borderline rispetto alla legge, al consumo di droga e di ulteriori infrazioni legali. Da perfetta stand up comedy l’invocazione a Berlinguer che dall’oltretomba gli si affaccia in sogno per chiedergli che fine ha fatto il Pci. Un sogno all’incontrario nelle risposte che Paolo Rossi gli fornisce descrivendo un quadro idilliaco che è l’esatto stravolgimento della realtà attuale. Graffiante, malinconico, lisergico, Rossi ha sprazzi sulfurei che sono il giusto antidoto alla banalità del reale. Dal gin tonic in quantità siderale alle riflessioni argute sulla sparizione delle Feste dell’Unità, la descrizione di un mondo di sinistra evaporato nelle brume del capitalismo, del teatro come merce, del posto fisso degli Stabili. Comicità da alto e basso, biografica e non di un guitto che molto ha dato anche alla televisione vivendo in contraltare satirico gli anni d’oro di Berlusconi, bersaglio ormai non più attivo e valido. C’è molta vita, dalla nascita alla vecchia nel segno di una parabola che non vuole finire e si riproduce anche con il tramite della mimesi letteraria. Si può scrivere infine che Paolo Rossi è vivo e satireggia insieme a noi.
data di pubblicazione:24/04/2021

da Antonio Jacolina | Apr 22, 2021
 Con la collana Time Crime la casa editrice Fanucci ha meritoriamente portato avanti un progetto rivolto agli appassionati del Poliziesco (nelle sue variegate forme) destinato a riscoprire una narrativa di genere, una letteratura forse di serie B, ma, comunque sia, una letteratura che è ormai uscita da tempo dai confini entro cui era stata rinchiusa dai pregiudizi di una Critica dotta.
Con la collana Time Crime la casa editrice Fanucci ha meritoriamente portato avanti un progetto rivolto agli appassionati del Poliziesco (nelle sue variegate forme) destinato a riscoprire una narrativa di genere, una letteratura forse di serie B, ma, comunque sia, una letteratura che è ormai uscita da tempo dai confini entro cui era stata rinchiusa dai pregiudizi di una Critica dotta.
Come sappiamo, dalle storie scritte per il pubblico delle riviste popolari americane (pulp magazine) negli anni ’20 e’30 del 1900, un pubblico fatto di lettori semplici e con pochi soldi e molti problemi, gente che voleva evadere dalla cruda realtà della quotidianità, è nato il cosiddetto Hard Boiled, quel sottogenere prima letterario e poi anche cinematografico che ha costituito un netto contraltare con il Giallo ed il Mistery tipicamente inglese. Qui c’è sempre un eroe solitario, disincantato e cinico che affronta il crimine nella strada, là ci sono invece … arsenico e vecchi merletti … Spesso poi questo eroe è un investigatore privato (reduce da qualche guerra), un vero e proprio archetipo del genere letterario oltre che di buona parte del cinema americano.
Mike Hammer il protagonista di Ti Ucciderò ha senza dubbio un suo posto d’onore nella narrativa poliziesca statunitense, ma ha di certo anche poco in comune con gli altri grandi detective … con il Philip Marlowe crudo ed al tempo stesso romantico di Chandler o con il Sam Spade puro e duro ma con qualche macchia di Hammett. Hammer è piuttosto un “duro”: brutale, cinico, senza scrupoli, violento, sciupafemmine, sessista e machista che fa giustizia da solo, anticipando quasi i futuri caratteri cinematografici dell’Ispettore Callagham o del Giustiziere della notte.
Ne è passato di tempo da quando nel 1947 uscì questo libro!! il romanzo che fin dalla sua prima apparizione diede l’immediata notorietà a Spillane facendone un grande autore di best seller che, all’epoca, non aveva altro concorrente che se stesso. Le sue storie hanno, in effetti, un po’ la patina del tempo e, di certo nel frattempo, numerosi altri autori e personaggi si sono fatti largo nel mondo del poliziesco dando tutti un tocco di maggior classe al genere. Non c’è dubbio poi che Hammer sia quanto di più lontano possa esserci da un protagonista politicamente corretto di oggigiorno, e che le sue avventure non abbiano nulla dei Polar attuali, tutti più o meno pretenziosamente impegnati anche sul piano sociale. Ciò non di meno il libro non è invecchiato e la sua lettura è ancora una lettura molto piacevole a farsi ed è come un’opportunità per prendere una boccata d’aria e di respirare e vivere le autentiche atmosfere di una volta. Un romanzo quindi da riscoprire con piacere, sia per l’intrigo poliziesco ben costruito e condotto (pur se con metodi diversi, lavorando e procedendo cioè a suon di pugni e pistolettate piuttosto che lavorando su indizi ed intuizioni), sia soprattutto, giova ribadirlo, per le atmosfere, le ambientazioni, le regole ed i costumi di una Società ormai lontanissima dalla nostra per valori e modi di vivere e relazionarsi.
Il romanzo è un vero ed autenticissimo Pulp hard boiled , un ritorno alle origini: brutale, incisivo, vigoroso, esagerato ed anche autoironico e divertente così come non abbiamo più abitudine di leggere, un racconto la cui violenza gratuita può e deve essere accettata solo ravvisandone tutta la sua inverosimiglianza. Un’occasione per un viaggio nel tempo ed una immersione in un’altra America, in altri stili di vita. La scrittura di Spillane era e resta ovviamente piacevole, scorrevole, diretta e semplice, i ritmi sostenutissimi fra continui colpi di scena, azione, sparatorie e baci.
Una lettura gradevole ed avvincente con il gusto delle cose del tempo che fu.
data di pubblicazione:22/04/2021

 C’è un modo di dire corrivo ma esauriente: ne ha viste più di Carlo in Francia! Trovatemi per analogia un giornalista nostrano che in capo a 65 anni di attività abbia un agenda telefonica (ora su smartphone) ricca come quella di Gianni Minà. Che detiene un altro primato aziendale in Rai: 17 lunghi anni di gavetta senza essere assunto. Amico di Pietro Mennea, di Diego Armando Maradona e del Papa in un filo crosso di connessioni ideologiche note solo a lui che riuscì a intrattenere per tutta una notte Fideò Castro pur di montare un’intervista scoop. Coraggio, empatia e sprezzante disistima del pericolo le qualità innate del cronista da battaglia che, partito da Torino, ha girato il mondo riempiendolo con le proprie passioni sudamericane e con il vivo senso della professione. Liquidato dalla Rai in un amen quando il ventennio berlusconiano gli ha scavato la fossa sotto i piedi. Come possono raccontare anche Luttazzi, Travaglio e Santoro. Ma il meglio era giù venuto, sotto la bandiera di Arbore, di illuminati esperimenti dell’azienda di Stato. Minà era capace di riunire in una notte romana nel più noto ristorante di Trastevere Robert De Niro, Muhammad Alì, Gabriel Garcia Marquez e Sergio Leone. In quella compendiosa foto c’era tutto Minà e il suo potete di fascinazione. Cronista d’assalto, incapace di fare il direttore, come dimostra la sua infelice esperienza a Tuttosport (testata mai nominata nel corso del libro). Le foto parlano più del testo. Un libro nato con una genesi lunga e difficile. Minà oggi over 80 si è avvalso della decisiva complicità di Fabio Stassi che ha registrato queste fluviali confidenze di una vita. A ruota libera, con un copione in divenire spezzettato in tanti capitoli, altrettanti flash di una ininterrotta esperienza professionale. Minà era l’anti-Marzullo, nemico della sedentarietà, delle frasi fatte, inevitabile nemico del potere costituito, in primis quello dell’imperialismo americano.
C’è un modo di dire corrivo ma esauriente: ne ha viste più di Carlo in Francia! Trovatemi per analogia un giornalista nostrano che in capo a 65 anni di attività abbia un agenda telefonica (ora su smartphone) ricca come quella di Gianni Minà. Che detiene un altro primato aziendale in Rai: 17 lunghi anni di gavetta senza essere assunto. Amico di Pietro Mennea, di Diego Armando Maradona e del Papa in un filo crosso di connessioni ideologiche note solo a lui che riuscì a intrattenere per tutta una notte Fideò Castro pur di montare un’intervista scoop. Coraggio, empatia e sprezzante disistima del pericolo le qualità innate del cronista da battaglia che, partito da Torino, ha girato il mondo riempiendolo con le proprie passioni sudamericane e con il vivo senso della professione. Liquidato dalla Rai in un amen quando il ventennio berlusconiano gli ha scavato la fossa sotto i piedi. Come possono raccontare anche Luttazzi, Travaglio e Santoro. Ma il meglio era giù venuto, sotto la bandiera di Arbore, di illuminati esperimenti dell’azienda di Stato. Minà era capace di riunire in una notte romana nel più noto ristorante di Trastevere Robert De Niro, Muhammad Alì, Gabriel Garcia Marquez e Sergio Leone. In quella compendiosa foto c’era tutto Minà e il suo potete di fascinazione. Cronista d’assalto, incapace di fare il direttore, come dimostra la sua infelice esperienza a Tuttosport (testata mai nominata nel corso del libro). Le foto parlano più del testo. Un libro nato con una genesi lunga e difficile. Minà oggi over 80 si è avvalso della decisiva complicità di Fabio Stassi che ha registrato queste fluviali confidenze di una vita. A ruota libera, con un copione in divenire spezzettato in tanti capitoli, altrettanti flash di una ininterrotta esperienza professionale. Minà era l’anti-Marzullo, nemico della sedentarietà, delle frasi fatte, inevitabile nemico del potere costituito, in primis quello dell’imperialismo americano.
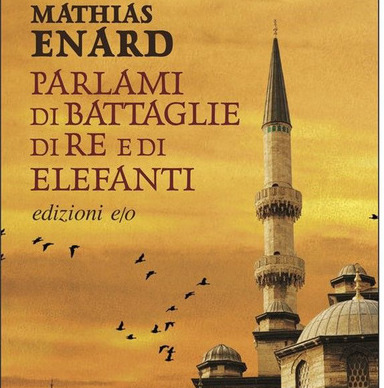














Gli ultimi commenti…