
da Maria Letizia Panerai | Set 29, 2008
Jon (Philip Seymour Hoffman) e Wendy (Laura Linney) Savage sono due fratelli adulti che vivono separatamente le loro vite, insoddisfatte sul piano affettivo-familiare e malamente realizzate su quello lavorativo. Lui, appassionato e specialista di teatro brechtiano, si accontenta di insegnare drammaturgia presso l’Università di Buffalo e di convivere con una donna, di nazionalità polacca, che dice di amare ma che vigliaccamente preferirà far tornare al suo paese piuttosto che impalmare; lei, trentanovenne, ha un impiego temporaneo a New York e conduce una vita frustrata dal perenne sogno di diventare autrice teatrale, scrive commedie autobiografiche che nessuno vuole pubblicare, e si consola vivendo una relazione, fatta di incontri fugaci e senza futuro, con il suo vicino di casa. Jon e Wendy hanno un padre, Lenny (Philip Bosco), che vive tranquillo e solo in Arizona, lontano da entrambi, distratto da se stesso e non amorevole, presente nei ricordi adolescenziali dei due fratelli come un genitore severo e dispotico, che un bel giorno comincia a manifestare segni di demenza senile, malattia che obbligherà i figli a prendersi cura di lui, dopo averlo fatto ricoverare a Buffalo in un centro di assistenza per anziani. Per assicurare la loro vicinanza al padre, i fratelli decidono di vivere insieme a casa di Jon: ma la convivenza coatta tra i due farà riemergere in entrambi alcune fragilità, vecchi rancori e amarezze, oltre a sensi di colpa accompagnati da generose manciate di tristezza.
In questo film, targato U.S.A., inusuale e delicato, si parla con realismo ed ironia della profonda umanità di cui sono intrisi i personaggi di Jon e Wendy, grazie anche ad interpreti degni di nota, provati sì dalla vita, ma che nonostante tutto riescono a dare all’anziano genitore quello che possono in attenzioni sgangherate, affetto e sostentamento, ed indubbiamente più di quanto lui non abbia mai dato loro, con un finale per il spettatore tutto da scoprire.
Scopri con un click il nostro voto: 

da Maria Letizia Panerai | Set 29, 2008
(Festival di Roma, 2007)
Ho letto da qualche parte che nella vita non è importante essere forti, quanto piuttosto sentirsi forti. Tratto dall’omonimo bestseller di Jon Krakauer, lo splendido film di Sean Penn racconta il “necessario” percorso interiore di un giovane ventiduenne, Christopher McCandless che, decidendo di dare ascolto alla propria voce di dentro, sarà portato senza alcun rimorso ad abbandonare tutto, gli affetti gli amici e la propria vita, per spingersi sino all’essenza di sé. Attraverso un reale avventuroso viaggio nella natura selvaggia, che porterà Christopher McCandless (Emile Hirsch) a spingersi sino in Alaska, egli percorrerà un metaforico viaggio nei meandri della propria giovane esistenza. Il protagonista voluto da Penn non è un eroe, anzi, ci viene dipinto in tutto il suo egoismo giovanile, in tutta la sua forza egocentrica, ed il regista sembra puntare volutamente il dito sulle sue scelte estreme, che spesso irritano lo spettatore. Splendida la colonna sonora, scelta ad arte anche per i testi. Mirabili le interpretazioni di William Hurt e M. Gay Harden, nel ruolo dei genitori di Chris: tipica coppia della middle-class americana, che obbligatoriamente e forzatamente dovranno ripensare, per il resto dei loro giorni, i principi e le ottuse convinzioni su cui avevano basato le loro esistenze borghesi.
Quando una volta in Alaska, al culmine del suo viaggio-percorso edipico, Chris tenterà di oltrepassare il fiume che lo separa dalla terra ferma e le acque in piena glielo impediranno – come a significare che certe scelte prive di mediazione e dialogo, una volta intraprese, divengono irreversibili – , egli non potrà fare altro che annotare sul suo diario di viaggiatore che la felicità è reale solo se condivisa.
Scopri con un click il nostro voto: 

da Maria Letizia Panerai | Set 18, 2008
Gran Torino, l’ultimo film di Clint Eastwood, è un’autentica magia! E non solo perché tecnicamente perfetto, ma anche per i tempi piacevolmente lenti con cui ci viene raccontata una storia che potremmo definire un vero e proprio testamento artistico e professionale che, le generose mani del suo regista nonché magnifico interprete, offrono allo spettatore.
Il grande vecchio Clint ha colpito ancora, consegnandoci un’opera sobria, profonda, di gran classe proprio come la Ford Gran Torino del 1972 mai guidata dal suo protagonista, ma tenuta sempre in garage con quell’antico rispetto che solo le persone d’altri tempi sentono per le cose.
Il regista, vestendo i panni del suo personaggio, usa quella rudezza che ha sovente caratterizzato molte altre sue interpretazioni del passato e riesce così, in maniera geniale, a parlarci contemporaneamente di temi importanti: dell’anima multietnica dell’America e del razzismo che l’accompagna, della diffidenza con cui spesso si guarda al diverso e della scoperta che la diversità è invece un valore, perché puoi trovare più familiarità in un estraneo che in un consanguineo, scoprendo magiche similitudini.
E’ un linguaggio maschio e rude quello di Clint, ma non per questo meno incline al sentimento, alla melanconica tenerezza: il suo eroe di origini polacche Walt Kowalski, ci conquista e ci incanta, come un saggio che conosce bene la vita e si può permettere di combattere a viso aperto la morte. Convinto assertore di un radicato spirito americano patriottico e tradizionalista, nonché veterano della guerra di Corea, Kowalski ringhia contro tutti come un cane rabbioso perché tutti lo irritano, dai familiari ai vicini di casa, nella squallida periferia di Detroit. Intriso di astio e pregiudizi non solo razziali ma anche generazionali, incattivito da un volontario isolamento perché schivo e con un carattere difficile, Walt ha però in sé la magia delle grandi persone che sanno redimersi, che sanno pentirsi di cose che non avevano mai osato confessare, che nonostante le rughe si concedono ancora il lusso di stupirsi e di imparare, che sanno capire quando arriva il tempo di essere generosi per dare un senso alla propria di vita, intenerendoci con i suoi ruvidi ed inossidabili ideali, con quei suoi modi antichi ma profondamente umani attraverso i quali filtra il mondo che lo circonda.
E’ infatti la semplicità, l’ingrediente con cui Clint Eastwood fa del suo film un autentico capolavoro, consegnandoci con la civetteria di navigato artista, il testamento di un uomo che strizza l’occhio alla morte, in modo superstizioso oltre che geniale, nella scena finale del film, lasciandoci una ultima splendida prova da attore e la promessa di una ancora longeva carriera da regista.
Scopri con un click il nostro voto: 

da Alessandro Pesce | Set 12, 2003
E’ la storia di Theo e Isabelle, gemelli , con relativo legame sconvolgente ed unico. Essi vivono di immaginario cinematografico, quando non sono in cineteca a gustarsi Samuel Fuller o Fred Astaire, Godard o Greta Garbo, Freaks o Mouchette, vivono chiusi in casa fingendo sempre come in un film, o replicando le finzioni viste sullo schermo; e la finzione diventa vita in tutte le sue manifestazioni , sesso e morte compresi. Incontrano Matthew, studente americano e sentendolo affine lo fanno partecipe della loro “rappresentazione” . E’ soltanto un aborto di vita, però, questo rapporto, perché i due gemelli (e viene il sospetto che potrebbe trattarsi di una sola persona con due identità sessuali) sono troppo ancorati al loro mondo interiore. Finché un giorno la Storia, quella vera, li scuote arrivando con un sasso dalla finestra di casa, impedendo la morte di Isabelle ma proiettandoli nella realtà. E’ l’infanzia perduta, o soltanto la continuazione della finzione?
Questa è anche la storia di una rivoluzione mai cresciuta, di un’ illusione rimasta tale, che tuttavia ha segnato definitivamente la vita di noi tutti perché da allora nulla è stato mai più uguale, nel bene e nel male e forse le vere rivoluzioni sono queste, le metamorfosi del pensiero e del modo di vivere. E l’entusiasmo dei ragazzi evocato nel film è un fermento, una speranza che, a detta dell’autore, mancherebbe alle nuove generazioni.
Trattandosi di illusioni infine questa NON PUÒ NON essere pure la storia dell’illusione cinematografica: The Dreamers, intitola Bertolucci, quasi accreditando l’antico luogo comune cinema = sogno ma nel film ricorda altresì la frase dei Cahiers di cinema secondo cui il regista è voyeur che spia dal buco della serratura, come lui stavolta, appunto, spia tre sognatori del 68.
Tutto senza rimpianti, naturalmente come nel pezzo di Edith Piaf che sottolinea il finale (è la seconda volta in pochi giorni, dopo il film dei Cohen, che si ascolta “non je ne regrette rien” al cinema !!)….Non mi meraviglia che questo mare di cinema su cinema e cinema nel cinema che è The dreamers abbia affascinato un critico come Ghezzi. Secondo me, invece, mi spiace, è il solito Bertolucci degli ultimi anni, splendido in alcune sequenze (quella iniziale alla Cinemathèque per esempio) ma irritante in altre, spesso ingenuo, ambiguo anziché no, sfilacciato, meno asciutto che nel suo penultimo film L’Assedio, e ancora lontano anni luce dall’autore di Partner o di Strategia del ragno, e anche dallo stra-citato Ultimo tango : ma quello è stato un suo periodo aureo che come il 68 non tornerà mai più.
Scopri con un click il nostro voto: 

da Alessandro Pesce | Apr 5, 2003
La dolce Camilla dovette subire, a soli 13 anni, le molestie di un vecchio signore, come pegno per un debito di gioco del di lei padre, e da quel momento la sua psiche si incanalò verso un percorso di vocazione al martirio (come per tutta la durata del film ci ricorda una statuetta di Giovanna D’Arco piena di ragnatele). Tale condizione caratterizzerà tutti i suoi rapporti col mondo e le persone che la circondano.
Ma, come si sa, l’estrema bontà e la castità sovente sono una forma di perversione acuta e così quella che tutti immaginano come l’angelo del bene sarà la passiva artefice del disastro.
É questo personaggio straordinario ad emergere nel gioco di dualismi che si dipana nel film: gli uomini e le donne, il fratello vero e quello pseudo-fittizio (sostituito nella culla con una trovata da telenovela), la bontà e la trasgressione, l’ordine e il disordine.
E il principio dell’incertezza, che governa maldestramente le azioni, è null’altro che la fragilità dell’uomo al cospetto dei misteri del destino e della psiche. Il tutto è raccontato in un Portogallo attuale ma al contempo fuori da ogni dimensione temporale, con lo stile straniato che De Oliveira usa spesso. Questo succede sin dalla prima scena, dove i due fratelli Roper, curiosi intellettuali di provincia, chiacchierando su un battello ci svelano gli antefatti di coloro che saranno i protagonisti a mo’ di prologo. Ma non meno importante dell’impianto teatrale sono gli scorci del paesaggio portoghese (siamo dalle parti di Oporto) che si inseriscono, puntuali e significativi, nel racconto. Certo bisognerebbe rivedere il film in moviola per tentare di decifrare gli innumerevoli simboli e comprendere tutti i dialoghi e i filosofemi seminati nella pellicola da questo sempre lucidissimo allora ultranovantenne Maestro del cinema, morto a 106 anni l’altro giorno

da Alessandro Pesce | Feb 8, 2003
Il passato è un paese straniero dove tutto si svolge in maniera diversa: Harold Pinter, dalla sceneggiatura di The go beetween.
Un film meraviglioso sulla funzione della memoria, sui suoi meccanismi, ambigui e incerti, a cui tuttavia ci si aggrappa nel terrore del vuoto atemporale.
Non è soltanto la storia di un amore impossibile, né solo un ritratto crudele dell’epoca vittoriana, il fulcro sta nel rapporto tra passato e presente, il ragazzino che fu piccolo corriere tra i due amanti e testimone di quel dramma, ormai è un vecchio signore che ripercorre quegli accadimenti perché non si ripetano gli stessi errori o semplicemente per “ ritrovarsi “, nella speranza che in un processo inverso a quello di Dorian Gray, ripercorrendo quella storia i connotati della sua gioventù tornino chiari, ma invano.
Il rapporto col passato è difficile, lo si ricostruisce dandogli dei significati, riempiendolo di contenuti, perché altrimenti mancherebbe di concretezza il nostro presente e la nostra immagine rimarrebbe labile e incerta. Senza i punti fermi per quel che riguarda il “come eravamo” anche il “come siamo” (le convenzioni, anche di linguaggio), non c’è che angoscia e inquietudine.
E’ la poetica di Harold Pinter, sceneggiatore e scrittore tra i più grandi del Novecento, autore, non a caso, dell’unica riduzione intiera della Recherche che avrebbe dovuto dirigere proprio Losey e poi invece rimasta per sempre nel cassetto.
Quel che rimane in mente del film, a memoria lontana, sono soprattutto le ricorrenti scene di corsa nella campagna inglese estiva, del ragazzino che porta le lettere tra la tenuta della bella aristocratica Julie Christie e la fattoria del rude e tormentato Alan Bates. Mi piace pensare che quelle corse fossero metafora non soltanto della distanza tra due mondi ma, alla luce di quel che ho scritto, di due momenti della vita, separate come galassie lontane.
Nella ricostruzione necessaria del nostro passato non si sa dove finisce il fittizio e comincia il reale.

da Alessandro Pesce | Feb 5, 2003
La prima volta che molti anni fa vidi Nodo alla gola non mi aveva colpito particolarmente, mi pareva solo un buon esercizio di teatro filmato, forse perché privo di certi virtuosismi a cui il Hitchcock ci aveva abituati, ad esempio le 70 inquadrature di macchina da presa nella doccia di Psyco.
A rivederlo adesso invece mi sembra una pellicola particolarissima e sorprendente.
Alla base c’è una pièce di Patrick Hamilton, Coktail per un cadavere, che è un gioco giallo da risolvere ma è anche un incubo claustrofobico, un puzzle teso di rapporti psicologici tra cinque personaggi, che anticipa in qualche modo situazioni e linguaggio di certo “teatro dell’assurdo” che ancora non era in voga all’epoca della pellicola.
Hitchcok risolve girando tutto con un’unica ripresa. L’impressionante incipit consta di un urlo maschile e la scena si apre su due amici e un cadavere.
L’azione si svolge nella stanza e non ci sono stacchi di telecamera per un’ora e venti, quasi come se fosse la ripresa di una rappresentazione teatrale, con la differenza che il regista sposta la sua attenzione dove gli è più congeniale per ottenere il suo scopo.
Bellissima la sequenza in cui la governante sparecchia il cassone con dentro il cadavere: macchina fissa con lei che fa avanti e indietro dal cassonetto alla cucina con pochi oggetti alla volta.
Forte anche la suspence.
Molti registi che traggono film da commedie limitandosi a riprendere un ambiente in maniera piatta dovrebbero rivedersi Nodo alla gola, anche i tanto osannati Carnage e Venere in pelliccia di Polanski, impallidiscono al confronto.
E non c’è solo tecnica, è naturale, ma grande attenzione all’atmosfera: basta sentire le frasi distratte di Rupert (James Stewart), l’arroganza di Brendon (John Dall) o l’ansia incontrollabile di Philp (Farley Granger) ma di questo va dato merito anche all’autore del testo. Riservata, elegante e non bacchettona l’allusione al tono omosessuale. É chiaro, la censura ha influito ma certe cose si intuiscono benissimo.
Un film anomalo, senza giri vorticosi, senza le ” bionde” di Hitchcock ma griffato e a suo modo speciale.

da Alessandro Pesce | Set 25, 2002
Davvero splendido questo ultimo Olmi. Strano connubio di opera didattica (con soluzioni stranianti e brechtiane come il parlare allo spettatore in quarta parete) e visionaria (grazie specialmente a una fotografia stupenda e surreale) il film prescinde da un giudizio storico per concentrare l’attenzione sulla figura di Giovanni dalle bande nere, come santo laico. Non sappiamo se Giovanni combatte per una causa giusta o meno, non ci interessa, ci interessa il suo coraggio e la sua forza etica, attorno a lui solo mezze figure. Oltre a questa icona dominante, moltissimi altri sono gli spunti che il film propone: la realtà della guerra, la guerra e la morale, la morale e la politica, e soprattutto il tema del cambiamento epocale, segnato in questo caso dalla scoperta delle armi da fuoco, che saranno fatali al nostro eroe, ma che è possibile applicare a tantissimi altri casi, sul piano sociale e su quello del privato anche nel mondo attuale. A questo proposito, ho trovato toccante per esempio quando Giovanni viene ferito dalle armi: ognuno di noi, in senso lato, si può riconoscere nella sconfitta quando è provocata dall’ inadeguatezza rispetto al “nuovo”, tanto più se nella lotta sei animato da una passione che però alla fine si rivela impotente.
Scopri con un click il nostro voto: 
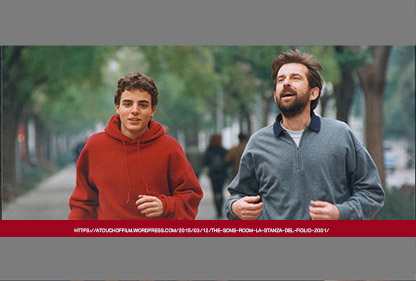
da Alessandro Pesce | Set 29, 2001
Comincio col dire che non sono completamente d’accordo su chi, ed è la maggioranza, sostiene che Moretti ha rinunciato all’ autobiografia, al suo orticello, all’autarchia, per esplorare finalmente la dimensione del racconto in terza persona. Certo, ha lasciato l’ormai in-filmabile Roma per attraversare l’Appennino e scegliere una città di mare come Ancona, poco vista al cinema. Certo, ha messo da parte il suo caro diario, le battute di attualità politica, la messa in scena della moglie vera e del figlio vero, ma si è portato sicuramente dietro il suo bagaglio di ossessioni e nevrosi. Ce lo vuol far capire lui stesso, subito, all’inizio del film, quando lo psicanalista Giovanni Sermonti.
il suo nuovo personaggio, tornando a casa dal footing, rispondendo al telefono dice qualcosa del tipo (cito a memoria): sono io, sono Giovanni. Come si sa, nel cinema di Moretti, nessuna battuta o scena o dettaglio è lasciato al caso, come un piccolo Kubrick (il paragone non scandalizzi, sto parlando solo di metodo). E pertanto quella battuta non può, secondo me, che significare “sono sempre io”. E d’altronde i pazienti dello psicanalista appaiono degli alter ego di Nanni, ognuno
rappresentante di una paranoia del passato: c’è la golosità, la mania di classificazione, la presenza del tumore da combattere. Soltanto il paziente erotomane mi risulta davvero strano e mi ha spiazzato: che ci voglia accennare a una sua nuova ossessione? Spero di no per lui, eppure è un ruolo non piccolo, con tre scene ed è affidato a un attore importante come Accorsi e quindi qualcosa dovrà rappresentare:…Lo psicanalista ha anche una famiglia, molto normale e per certi versi
esemplare: una moglie che lavora in una casa editrice (Laura Morante, mai vista così brava), c’è comunicazione, comprensione, dialogo, si fa ancora l’amore, si traduce il latino insieme coi figli, hanno una casa bella, funzionale, piena di libri ma non di lusso come ci si aspetterebbe da uno stimato professionista e soprattutto non c’è ombra di cellulare e tv e computer: se ci sono, sono sempre spenti. E’ forse il tipo di famiglia ideale anticonsumistica e antiberlusconiana che starebbe alla base di una sorta di “rifondazione della borghesia” che il Nostro nel suo giansenismo di sinistra senz’altro auspica? Si tratterebbe allora di un aspetto politico seppure trasversale. Ma proprio uno dei familiari, il figlio Andrea, un ragazzo buono e ubbidiente, appare un pò distante da questa armonia; il padre lo vorrebbe più competitivo (e lui non lo è), più autonomo (e lui si fa trascinare in un furtarello a scuola), più aperto; e poi hanno gusti sportivi e musicali diversi. nella famosa scena in cui, in auto, cantano tutti il celeberrimo pezzo di Paolo Conte “Insieme a te non ci
sto più”, metaforicamente, Andrea è l’ultimo a unirsi al coro. E proprio lui diviene protagonista involontario della vicenda con quel che gli capita. A questo punto entra in scena il Dolore ed è il Dolore che il senso comune conosce come il più grande che possa capitare. Tutta la parte che precede il lutto e lo descrive è saggio di esemplare regia, che usa pochi ma decisi tratti (la scena al mercatino, la scena della bara). Dopodiché tutto sarà diverso nella famiglia: i rapporti, la vita quotidiana, il lavoro, le domeniche, perché come dice Moretti è un tipo di dolore che divide anziché unire (è lo stesso dolore che aveva diviso in Turista per caso, Via col vento e altre pellicole).
Tranne la scena del luna park, veramente brutta anche perché svela i limiti del Moretti attore (scena che è l’unica mia riserva insieme al montaggio un pò trascurato), tutto il resto del secondo tempo è
sorprendentemente toccante e misurato, fino a quel finale sulla spiaggia ligure (quasi al confine francese: un’altra metafora o una dichiarazione programmatica?), con sottofondo di Brian Eno che rimane un pò così, tra l’ottimismo moderato ed altre imponderabili sensazioni e che pone altri interrogativi in questo film da vedere e rivedere.
Scopri con un click il nostro voto: 

da Alessandro Pesce | Gen 1, 2001
Leone d’Oro a Venezia nel 2000, questo film è l’ennesima dimostrazione che il cinema che viene dall’Oriente (medio o estremo che sia) è stato il più interessante e fresco in circolazione negli anni zero. Il cerchio del titolo è ciò che unisce una finestrella di un ospedale, dove comincia la storia col ferale annuncio è nata, è femmina e una finestrella di un carcere, dove finiscono o tornano le protagoniste del film. Ma più che la denuncia, è notevole il girato con la macchina a mano che segue i personaggi passo passo; niente paesaggi alla Kiarostami (l’altro grande iraniano), l’unico paesaggio è in un quadro al mercatino che affascina due povere donne, come un Eden irraggiungibile. Capolavoro.
Scopri con un click il nostro voto: 










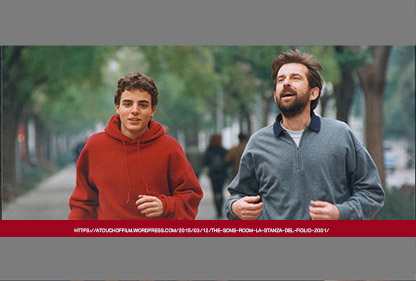






Gli ultimi commenti…