
da Daniele Poto | Set 28, 2019
 Ci siamo disposti con il massimo di disponibilità e di atteso piacere nel leggere l’ennesima investigazione del commissario Kostas Charitos, rimanendo alla fine delusi perché in oltre 350 pagine di abile letteratura, sul fondale di una Grecia apparentemente risanata, la sorpresa e le emozioni sono decisamente mancate. Come se l’obbligo contrattuale di fornire su commissione l’ennesima puntata della saga avesse prosciugato la fantasia di un autore ormai più che ottantenne, una sorta di Camilleri ellenico. Sono più singolari i minuetti familiari (a volte però distraenti), le discussioni gastronomiche in famiglia del plot poliziesco, davvero esile e banale, trascinato ineluttabilmente verso un finale piatto e senza scosse. Non c’è tensione nelle ricerche di Charitos, molta routine e le difficoltà a guidare nel caotico traffico di Atene. Un deja vu estenuato che determina attimi di noia e una curiosità inappagata per una storia che si trascina stancamente verso un epilogo non prevedibile ma tutt’altro che emozionante. L’assassino (gli assassini) compaiono come figure comparse durante la narrazione ma non appassionano e il tema della crisi e della povertà della vita in Grecia non è un alibi suadente per giustificare le loro azioni. Il libro scorre ma non incide, racconta ma non graffia. Come se l’autore navigasse a vista verso un finale abbastanza qualunque. Le vittime sono altrettanti ipocriti ma i carnefici non sono soggetti migliori né altamente credibili. Dietro l’Esercito degli Idioti Nazionali c’è la metafora di un mondo ingiusto, della Banca Centrale Europea e di un’unione continentale ben lontana dall’essere realizzata. Tutto molto prosaico e didascalico verso un lavoro ideologicamente a tesi, non sostenuto da una trama altrettanto ambiziosa e, diciamo pure, all’altezza del compito. Terminato il libro viene voglia di confrontare il risultato con le puntate precedenti. E il confronto è evidentemente piuttosto impari per il più letto autore della Grecia contemporanea.
Ci siamo disposti con il massimo di disponibilità e di atteso piacere nel leggere l’ennesima investigazione del commissario Kostas Charitos, rimanendo alla fine delusi perché in oltre 350 pagine di abile letteratura, sul fondale di una Grecia apparentemente risanata, la sorpresa e le emozioni sono decisamente mancate. Come se l’obbligo contrattuale di fornire su commissione l’ennesima puntata della saga avesse prosciugato la fantasia di un autore ormai più che ottantenne, una sorta di Camilleri ellenico. Sono più singolari i minuetti familiari (a volte però distraenti), le discussioni gastronomiche in famiglia del plot poliziesco, davvero esile e banale, trascinato ineluttabilmente verso un finale piatto e senza scosse. Non c’è tensione nelle ricerche di Charitos, molta routine e le difficoltà a guidare nel caotico traffico di Atene. Un deja vu estenuato che determina attimi di noia e una curiosità inappagata per una storia che si trascina stancamente verso un epilogo non prevedibile ma tutt’altro che emozionante. L’assassino (gli assassini) compaiono come figure comparse durante la narrazione ma non appassionano e il tema della crisi e della povertà della vita in Grecia non è un alibi suadente per giustificare le loro azioni. Il libro scorre ma non incide, racconta ma non graffia. Come se l’autore navigasse a vista verso un finale abbastanza qualunque. Le vittime sono altrettanti ipocriti ma i carnefici non sono soggetti migliori né altamente credibili. Dietro l’Esercito degli Idioti Nazionali c’è la metafora di un mondo ingiusto, della Banca Centrale Europea e di un’unione continentale ben lontana dall’essere realizzata. Tutto molto prosaico e didascalico verso un lavoro ideologicamente a tesi, non sostenuto da una trama altrettanto ambiziosa e, diciamo pure, all’altezza del compito. Terminato il libro viene voglia di confrontare il risultato con le puntate precedenti. E il confronto è evidentemente piuttosto impari per il più letto autore della Grecia contemporanea.
data di pubblicazione:28/09/2019
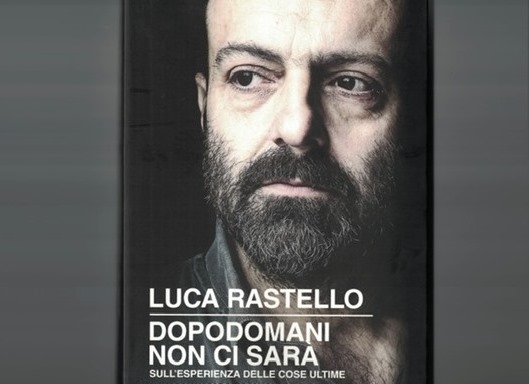
da Daniele Poto | Set 18, 2019
 Un pervasivo e inquietante senso della fine per l’opera finale di un autore sottovalutato, pubblicato in questo caso post mortem con la stima recensiva di personaggi come Roberto Saviano, Nicola Lagioia, Goffredo Fofi, Giuseppe Culicchia. Nemico spietato del politicamente corretto e del buonismo, Rastello ha lottato per dieci anni con una malattia oggi curabile, scandendo il tempo alla rovescia, i suoi sinistri e ferali rintocchi, con considerazioni profonde. Il senso della fine aleggia nelle pause con considerazioni ultimativa e non banali, prive di panico e di orgasmo, offerte con lucidità da chi, per tempo, ha saputo convivere con quello che succederà, peraltro non rinunciando a combattere. Dunque pezzi di arte varia. Dall’esperienza ospedaliera, all’approfondimento della tragedia greca; da una deriva routinaria del volontariato alla critica distaccata della virtualità e di un futuro sfuggente o non decifrabile. L’eredità letteraria e/o testamentaria che ci lascia questo autore richiede spesso una seconda lettura. Le speculazioni, sapendo quello che succederò, somigliano alle profezie. Vicino all’abisso si vede la realtà con un’altra prospettiva, più distaccata e vera. Questo sembra suggerirci l’autore. Nel blog del malato riottoso l’autore ha accompagnato il decorso della malattia con ironia cercando compagni di strada affettuosi e singolari, uniti da quella deriva che accomuna più che mai. Dunque un testo che assimila la letteratura alla saggistica in una diaristica personale di peso e spessore. Che ci fa apprezzare la profondità dell’oggetto-libro di fronte alla caducità e alla banalità del male. Riflette una visione urticante e anti-economicistica. Banale parlare di valori? Qualcuno sembra disposto ancora a crederci. E qualcuno a seguirlo. Rastello è stato scrittore ma anche militante, attivista nei luoghi più sconvolti della guerra nel pianeta. Già direttore di Narcomafie ha conosciuto in trincea il male e poi ha dovuto combatterlo sotto la forma di una malattia subdola e strisciante. L’esperienza delle cose ultime lascia il segno. Indelebilmente.
Un pervasivo e inquietante senso della fine per l’opera finale di un autore sottovalutato, pubblicato in questo caso post mortem con la stima recensiva di personaggi come Roberto Saviano, Nicola Lagioia, Goffredo Fofi, Giuseppe Culicchia. Nemico spietato del politicamente corretto e del buonismo, Rastello ha lottato per dieci anni con una malattia oggi curabile, scandendo il tempo alla rovescia, i suoi sinistri e ferali rintocchi, con considerazioni profonde. Il senso della fine aleggia nelle pause con considerazioni ultimativa e non banali, prive di panico e di orgasmo, offerte con lucidità da chi, per tempo, ha saputo convivere con quello che succederà, peraltro non rinunciando a combattere. Dunque pezzi di arte varia. Dall’esperienza ospedaliera, all’approfondimento della tragedia greca; da una deriva routinaria del volontariato alla critica distaccata della virtualità e di un futuro sfuggente o non decifrabile. L’eredità letteraria e/o testamentaria che ci lascia questo autore richiede spesso una seconda lettura. Le speculazioni, sapendo quello che succederò, somigliano alle profezie. Vicino all’abisso si vede la realtà con un’altra prospettiva, più distaccata e vera. Questo sembra suggerirci l’autore. Nel blog del malato riottoso l’autore ha accompagnato il decorso della malattia con ironia cercando compagni di strada affettuosi e singolari, uniti da quella deriva che accomuna più che mai. Dunque un testo che assimila la letteratura alla saggistica in una diaristica personale di peso e spessore. Che ci fa apprezzare la profondità dell’oggetto-libro di fronte alla caducità e alla banalità del male. Riflette una visione urticante e anti-economicistica. Banale parlare di valori? Qualcuno sembra disposto ancora a crederci. E qualcuno a seguirlo. Rastello è stato scrittore ma anche militante, attivista nei luoghi più sconvolti della guerra nel pianeta. Già direttore di Narcomafie ha conosciuto in trincea il male e poi ha dovuto combatterlo sotto la forma di una malattia subdola e strisciante. L’esperienza delle cose ultime lascia il segno. Indelebilmente.
data di pubblicazione:18/09/2019

da Daniele Poto | Ago 30, 2019
 Parenti serpenti? La famiglia è un bel pezzo della società civile italiana ma spesso è un microcosmo che riserva sorprese. Famiglie protette dal familismo e da segreti inconfessabili. Da questo viluppo si dipana la storia complicata che Mara Fux disciplina con maestria. Tra parentele insospettabili, coperture moraliste e una vita che comunque si produce come in una recita di fronte a continui disvelamenti e a cambi di prospettiva. Un punto di forza nei dialoghi che fanno avanzare la trama attraverso le contraddizioni e i conflitti dei protagonisti. La curiosità sembra l’impulso predominante che spinge la protagonista a non accontentarti della realtà superficiale ma la indice a frugare nell’albergo genealogico alla ricerca di una ricostruzione non fittizia del reale e dell’esistente. A fronte della pigra acquiescenza di chi la circonda si riafferma un perentorio desiderio di parresia, di girare le carte coperte e a addivenire alle rivelazioni possibili. La tesi non è sviluppata come un teorema perché s’intreccia e s’interseca con una vita dedita al lavoro, alle pubbliche relazioni, al marketing nel mondo dello spettacolo ed anche su questo versante vengono scritte parole non banali che mostrano la vera faccia dello show business. La capacità di padroneggiare la materia sempre più incandescente del plot è uno dei sicuri punti di forza del libro. Che non ha toni drammatici ma pacati e come in un andamento a spirale conduce il lettore a cibarsi della stessa ansia di verità della narratrice. Perché si sa di verità non si è mai sazi. La famiglia che nasconde segreti dietro un’apparente normalità potrebbe essere una qualunque delle famiglie italiane che tacciono e si nascondono di fronte all’evidenza di parentele scomode se non addirittura negate. Istituzione in crisi la famiglia, per alcuni baluardo da rilanciare. Certo, un valore che lo stato già sociale oggi poco difende. Di qui l’impressionante crisi di natalità di quello che una volta era il Belpaese.
Parenti serpenti? La famiglia è un bel pezzo della società civile italiana ma spesso è un microcosmo che riserva sorprese. Famiglie protette dal familismo e da segreti inconfessabili. Da questo viluppo si dipana la storia complicata che Mara Fux disciplina con maestria. Tra parentele insospettabili, coperture moraliste e una vita che comunque si produce come in una recita di fronte a continui disvelamenti e a cambi di prospettiva. Un punto di forza nei dialoghi che fanno avanzare la trama attraverso le contraddizioni e i conflitti dei protagonisti. La curiosità sembra l’impulso predominante che spinge la protagonista a non accontentarti della realtà superficiale ma la indice a frugare nell’albergo genealogico alla ricerca di una ricostruzione non fittizia del reale e dell’esistente. A fronte della pigra acquiescenza di chi la circonda si riafferma un perentorio desiderio di parresia, di girare le carte coperte e a addivenire alle rivelazioni possibili. La tesi non è sviluppata come un teorema perché s’intreccia e s’interseca con una vita dedita al lavoro, alle pubbliche relazioni, al marketing nel mondo dello spettacolo ed anche su questo versante vengono scritte parole non banali che mostrano la vera faccia dello show business. La capacità di padroneggiare la materia sempre più incandescente del plot è uno dei sicuri punti di forza del libro. Che non ha toni drammatici ma pacati e come in un andamento a spirale conduce il lettore a cibarsi della stessa ansia di verità della narratrice. Perché si sa di verità non si è mai sazi. La famiglia che nasconde segreti dietro un’apparente normalità potrebbe essere una qualunque delle famiglie italiane che tacciono e si nascondono di fronte all’evidenza di parentele scomode se non addirittura negate. Istituzione in crisi la famiglia, per alcuni baluardo da rilanciare. Certo, un valore che lo stato già sociale oggi poco difende. Di qui l’impressionante crisi di natalità di quello che una volta era il Belpaese.
data di pubblicazione:30/08/2019
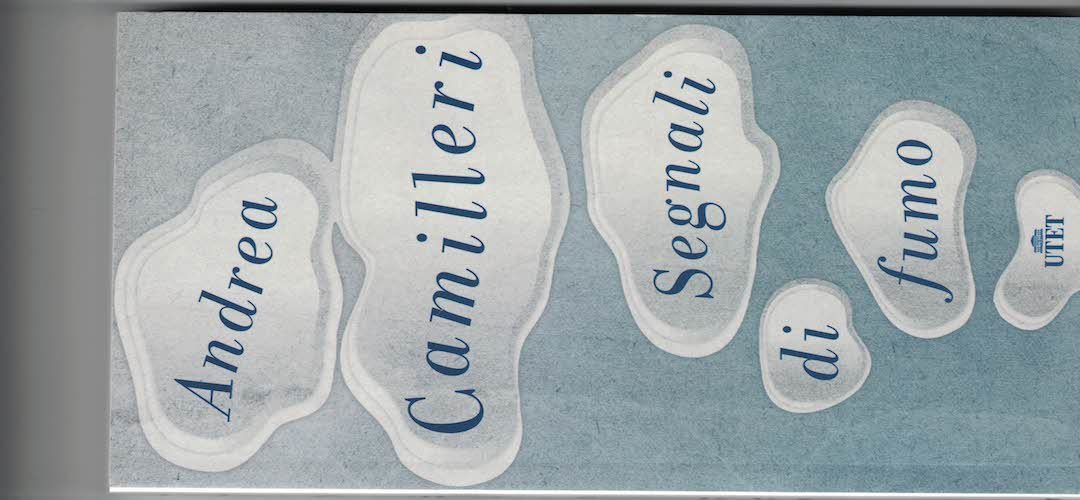
da Daniele Poto | Ago 26, 2019
 In un’estate foriera di dolorosi lutti l’ultimo libro di Camilleri è commercialmente e editorialmente una preda ghiotta. In veste grafica un po’ dimessa però è l’ultimo regalo dello scrittore siciliano, non si sa quanto propenso alla pubblicazione di questi pensieri sparsi, un diario di viaggio, appunti in libertà sulla vita e sull’esistenza. Non c’è un ordine preciso di catalogazione perché si prescinde dal criterio cronologico. C’è una numerazione che si spinge fino al 142 per indicarci la trama intellettuale, talvolta intimista, talvolta storica, di uno dei più grandi narratori scoperti nel secolo breve, affermatosi in tarda età, immortalmente reso celebre dal personaggio di Montalbano. C’è tanta Sicilia e tanta vecchiezza in questi ritrattini che ci mostrano l’autore nelle pratiche casalinghe di scrittura. Quando mette il vestito buono in omaggio al lettore e si dedica per qualche ora della mattina all’esercizio preferito e amato della scrittura. Si avverte anche stanchezza perché in una riflessione l’autore la confessa manifestatamente, sazio di tessere trame, forsennatamente richiestegli dagli editori. L’arco temporale è vasto. Ci sono situazioni ripensate del fascismo e del dopoguerra in un “Confesso che ho vissuto” umano, persino troppo umano. Pensatore laico, manifestatamente di sinistra, critico sull’imbastardimento della politica e dei costumi, a tratti dissacrante. Un vecchio palesemente giovane perché fresco di mente e di reazioni. Immerso nel suo tempo ma anche censore del mainstream corrente. Chi vuole conoscere a fondo predilezioni e fobie di Camilleri potrò piacevolmente immersi in questa lettura a tratti aneddotica ma sembra sostenuta da uno stile colloquiale e salottiero che mette infinitamente a proprio agio il lettore. Un’opera minore ma anche un messaggio di congedo dal mondo, quasi anticipato qui e lì da toni pessimisti e distaccati. Quasi un presagio del distacco a venire. Un piccolo testamento saggistico che aggiunge cumuli di grandezza a uno scrittore vicino al popolo. Nel segno migliore di quest’ultimo sostantivo.
In un’estate foriera di dolorosi lutti l’ultimo libro di Camilleri è commercialmente e editorialmente una preda ghiotta. In veste grafica un po’ dimessa però è l’ultimo regalo dello scrittore siciliano, non si sa quanto propenso alla pubblicazione di questi pensieri sparsi, un diario di viaggio, appunti in libertà sulla vita e sull’esistenza. Non c’è un ordine preciso di catalogazione perché si prescinde dal criterio cronologico. C’è una numerazione che si spinge fino al 142 per indicarci la trama intellettuale, talvolta intimista, talvolta storica, di uno dei più grandi narratori scoperti nel secolo breve, affermatosi in tarda età, immortalmente reso celebre dal personaggio di Montalbano. C’è tanta Sicilia e tanta vecchiezza in questi ritrattini che ci mostrano l’autore nelle pratiche casalinghe di scrittura. Quando mette il vestito buono in omaggio al lettore e si dedica per qualche ora della mattina all’esercizio preferito e amato della scrittura. Si avverte anche stanchezza perché in una riflessione l’autore la confessa manifestatamente, sazio di tessere trame, forsennatamente richiestegli dagli editori. L’arco temporale è vasto. Ci sono situazioni ripensate del fascismo e del dopoguerra in un “Confesso che ho vissuto” umano, persino troppo umano. Pensatore laico, manifestatamente di sinistra, critico sull’imbastardimento della politica e dei costumi, a tratti dissacrante. Un vecchio palesemente giovane perché fresco di mente e di reazioni. Immerso nel suo tempo ma anche censore del mainstream corrente. Chi vuole conoscere a fondo predilezioni e fobie di Camilleri potrò piacevolmente immersi in questa lettura a tratti aneddotica ma sembra sostenuta da uno stile colloquiale e salottiero che mette infinitamente a proprio agio il lettore. Un’opera minore ma anche un messaggio di congedo dal mondo, quasi anticipato qui e lì da toni pessimisti e distaccati. Quasi un presagio del distacco a venire. Un piccolo testamento saggistico che aggiunge cumuli di grandezza a uno scrittore vicino al popolo. Nel segno migliore di quest’ultimo sostantivo.
data di pubblicazione:26/08/2019
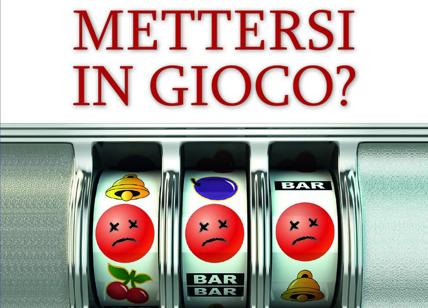
da Daniele Poto | Ago 26, 2019
 Armando Zappolini è l’onnipresente portavoce di Mettiamoci in gioco, una campagna in rete per la limitazione dell’azzardo che raccoglie sul territorio nazionale l’adesione di 39 sigle per un totale di nove milioni di iscritti. Trattasi di un bel pezzo di società civile che martella costantemente la politica per ottenere una legge di riordino per un gioco pericoloso che sottrae agli italiani risorse per 110 miliardi (dato del 2018) nel solo comparto legale. Il libro-testimonianza frutto dei suoi sforzi è una fotografia ragionata e credibile dell’esistente di un sistema proditorio che toglie denari all’economia, tempo a lavoro, hobby, iniziative sociali, nel nome del miraggio della grande vincita. La recente insensata vincita al Superenalotto di 209 milioni mostra la fatuità di un sistema che prema il singolo e deprime i perdenti (la collettività) nel segno di una svolta esistenziale che, da solo, il denaro non può dare. Il libro contiene storie e casi umani toccanti di vite e famiglie perse per questa seduzione, il brivido, l’adrenalina dietro una slot machine o persino acquistando caterve di “gratta e vinci”. L’azzardo alimenta una bolla economica, una spirale che va spezzata senza cadere nell’eccesso del proibizionismo. Lo spettro di un’educazione a vasto raggio (nelle scuole, nelle famiglie) è il miglior antidoto a questa piaga. Sottintende un lavoro a lungo termine che non è evidentemente nei piani della macchina istituzionale troppo impegnata a drenare risorse per colmare una piccola falla del debito pubblico. Conoscere i meccanismi dell’azzardo, anche attraverso questo manuale, è un contributo alla comprensione e alla cittadinanza resistente attiva. Non è accettabile che l’induzione all’azzardo crei migliaia di malati patologici, incrinando il tessuto sociale. Camuffare il gioco per azzardo è la grande manipolazione semantica di un sistema che conta su simpatie occulte e lobby manifeste, attive per contrastare in Parlamento ogni piano di riordino.
Armando Zappolini è l’onnipresente portavoce di Mettiamoci in gioco, una campagna in rete per la limitazione dell’azzardo che raccoglie sul territorio nazionale l’adesione di 39 sigle per un totale di nove milioni di iscritti. Trattasi di un bel pezzo di società civile che martella costantemente la politica per ottenere una legge di riordino per un gioco pericoloso che sottrae agli italiani risorse per 110 miliardi (dato del 2018) nel solo comparto legale. Il libro-testimonianza frutto dei suoi sforzi è una fotografia ragionata e credibile dell’esistente di un sistema proditorio che toglie denari all’economia, tempo a lavoro, hobby, iniziative sociali, nel nome del miraggio della grande vincita. La recente insensata vincita al Superenalotto di 209 milioni mostra la fatuità di un sistema che prema il singolo e deprime i perdenti (la collettività) nel segno di una svolta esistenziale che, da solo, il denaro non può dare. Il libro contiene storie e casi umani toccanti di vite e famiglie perse per questa seduzione, il brivido, l’adrenalina dietro una slot machine o persino acquistando caterve di “gratta e vinci”. L’azzardo alimenta una bolla economica, una spirale che va spezzata senza cadere nell’eccesso del proibizionismo. Lo spettro di un’educazione a vasto raggio (nelle scuole, nelle famiglie) è il miglior antidoto a questa piaga. Sottintende un lavoro a lungo termine che non è evidentemente nei piani della macchina istituzionale troppo impegnata a drenare risorse per colmare una piccola falla del debito pubblico. Conoscere i meccanismi dell’azzardo, anche attraverso questo manuale, è un contributo alla comprensione e alla cittadinanza resistente attiva. Non è accettabile che l’induzione all’azzardo crei migliaia di malati patologici, incrinando il tessuto sociale. Camuffare il gioco per azzardo è la grande manipolazione semantica di un sistema che conta su simpatie occulte e lobby manifeste, attive per contrastare in Parlamento ogni piano di riordino.
data di pubblicazione:26/08/2019

 Ci siamo disposti con il massimo di disponibilità e di atteso piacere nel leggere l’ennesima investigazione del commissario Kostas Charitos, rimanendo alla fine delusi perché in oltre 350 pagine di abile letteratura, sul fondale di una Grecia apparentemente risanata, la sorpresa e le emozioni sono decisamente mancate. Come se l’obbligo contrattuale di fornire su commissione l’ennesima puntata della saga avesse prosciugato la fantasia di un autore ormai più che ottantenne, una sorta di Camilleri ellenico. Sono più singolari i minuetti familiari (a volte però distraenti), le discussioni gastronomiche in famiglia del plot poliziesco, davvero esile e banale, trascinato ineluttabilmente verso un finale piatto e senza scosse. Non c’è tensione nelle ricerche di Charitos, molta routine e le difficoltà a guidare nel caotico traffico di Atene. Un deja vu estenuato che determina attimi di noia e una curiosità inappagata per una storia che si trascina stancamente verso un epilogo non prevedibile ma tutt’altro che emozionante. L’assassino (gli assassini) compaiono come figure comparse durante la narrazione ma non appassionano e il tema della crisi e della povertà della vita in Grecia non è un alibi suadente per giustificare le loro azioni. Il libro scorre ma non incide, racconta ma non graffia. Come se l’autore navigasse a vista verso un finale abbastanza qualunque. Le vittime sono altrettanti ipocriti ma i carnefici non sono soggetti migliori né altamente credibili. Dietro l’Esercito degli Idioti Nazionali c’è la metafora di un mondo ingiusto, della Banca Centrale Europea e di un’unione continentale ben lontana dall’essere realizzata. Tutto molto prosaico e didascalico verso un lavoro ideologicamente a tesi, non sostenuto da una trama altrettanto ambiziosa e, diciamo pure, all’altezza del compito. Terminato il libro viene voglia di confrontare il risultato con le puntate precedenti. E il confronto è evidentemente piuttosto impari per il più letto autore della Grecia contemporanea.
Ci siamo disposti con il massimo di disponibilità e di atteso piacere nel leggere l’ennesima investigazione del commissario Kostas Charitos, rimanendo alla fine delusi perché in oltre 350 pagine di abile letteratura, sul fondale di una Grecia apparentemente risanata, la sorpresa e le emozioni sono decisamente mancate. Come se l’obbligo contrattuale di fornire su commissione l’ennesima puntata della saga avesse prosciugato la fantasia di un autore ormai più che ottantenne, una sorta di Camilleri ellenico. Sono più singolari i minuetti familiari (a volte però distraenti), le discussioni gastronomiche in famiglia del plot poliziesco, davvero esile e banale, trascinato ineluttabilmente verso un finale piatto e senza scosse. Non c’è tensione nelle ricerche di Charitos, molta routine e le difficoltà a guidare nel caotico traffico di Atene. Un deja vu estenuato che determina attimi di noia e una curiosità inappagata per una storia che si trascina stancamente verso un epilogo non prevedibile ma tutt’altro che emozionante. L’assassino (gli assassini) compaiono come figure comparse durante la narrazione ma non appassionano e il tema della crisi e della povertà della vita in Grecia non è un alibi suadente per giustificare le loro azioni. Il libro scorre ma non incide, racconta ma non graffia. Come se l’autore navigasse a vista verso un finale abbastanza qualunque. Le vittime sono altrettanti ipocriti ma i carnefici non sono soggetti migliori né altamente credibili. Dietro l’Esercito degli Idioti Nazionali c’è la metafora di un mondo ingiusto, della Banca Centrale Europea e di un’unione continentale ben lontana dall’essere realizzata. Tutto molto prosaico e didascalico verso un lavoro ideologicamente a tesi, non sostenuto da una trama altrettanto ambiziosa e, diciamo pure, all’altezza del compito. Terminato il libro viene voglia di confrontare il risultato con le puntate precedenti. E il confronto è evidentemente piuttosto impari per il più letto autore della Grecia contemporanea.
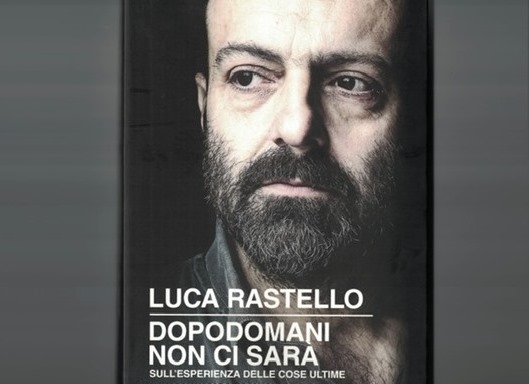

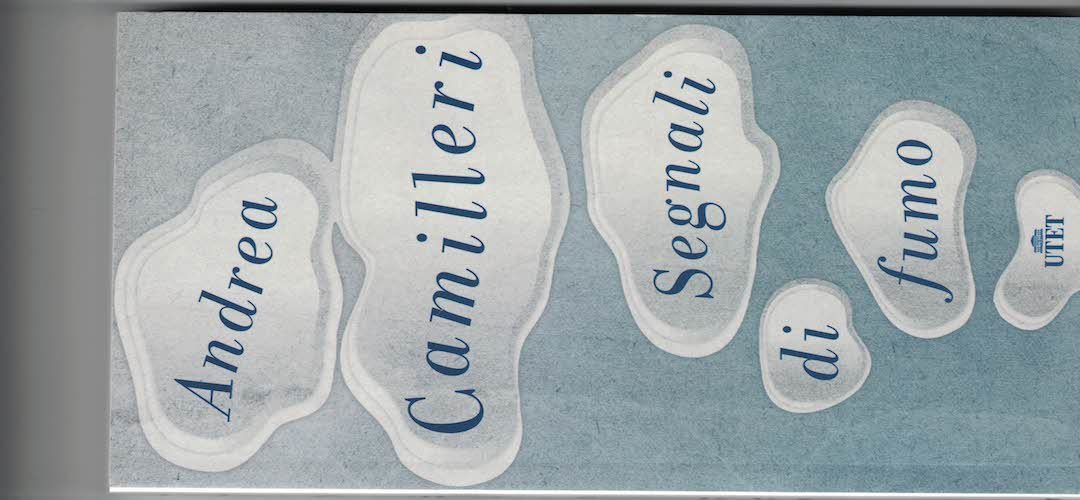
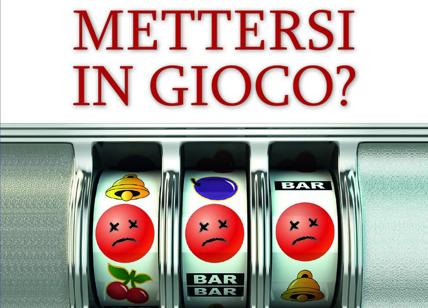





Gli ultimi commenti…