
da Rossano Giuppa | Apr 17, 2016
(Teatro Argentina – Roma, 13/17 aprile 2016)
Approda al teatro Argentina dal 13 al 17 aprile nel corso di una lunga tournèe italiana Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi, il bellissimo lavoro del Teatro delle Albe, con la drammaturgia e la regia di Marco Martinelli e l’interpretazione di Ermanna Montanari, dedicato a Aung San Suu Kyi simbolo della resistenza birmana, già premio Nobel per la pace.
Una figura forte e mistica, una donna rivoluzionaria e moderna, così legata alla propria gente da decidere di trascorrere vent’anni agli arresti domiciliari nel suo paese, vittima del regime militare. Una vita dedicata a costruire la pace, rinunciando ai propri figli, all’ultimo saluto all’amato marito, sacrificando la propria esistenza a favore di una rivoluzione spirituale, un impegno quotidiano fatto di meditazione, di lettura, di studio, approcciato con disciplina mentale per non cadere nella depressione, una rivoluzione eroica fatta di gesti e di parole, non cruenta, ma efficace, lenta e solida, vincente.
Una foto con il suo volto accattivante e mistico, una strana somiglianza con Ermanna Montanari, una distanza e nello stesso tempo una vicinanza emotiva con la Birmania, portano Marco Martinelli e la stessa Ermanna all’ennesima sfida: portare sul palcoscenico l’essenza di questa donna, declinandola secondo le modalità e le sfumature proprie del Teatro delle Albe.
Una sfida difficile, dedicata ad un’eroina di cui si è detto e scritto tutto. Un ritratto intimo, fatto di quotidianità, associato ad una ricostruzione puntuale documentaristica della storia, fatta a sua volta di immagini di repertorio, di interviste, discorsi. Una scenografia fatta di essenzialità e simboli associata ad un telegrafico percorso di didascalie luminose che scorrono sullo sfondo e che scandiscono le tappe del percorso di questa donna, regalando concretezza e spiritualità nello stesso tempo.
Un doppio binario di rappresentazione sostenuto dalla straordinaria capacità narrativa della protagonista, veramente unica nel modulare e trasmettere emozioni ed immagini, associata alla forte gestualità ritmica del coro, alle immagini fotografiche dei personaggi reali, ai suoni mistici e densi, che catturano e trasportano in un contesto molto più vicino ed universale.
data di pubblicazione:17/04/2016
Il nostro voto: 
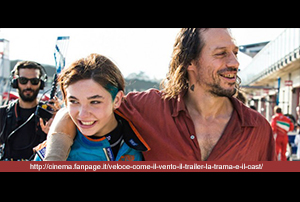
da Rossano Giuppa | Apr 8, 2016
“Se hai tutto sotto controllo, significa che non stai andando abbastanza veloce.” La frase del pilota di Formula 1 Mario Andretti è il secco start che dà il via al film di Matteo Rovere Veloce come il vento, fornendo da subito spunti inaspettati su quello che nella vita di ognuno è il contrasto tra desiderio di velocità e necessità di controllo.
La storia di Veloce come il vento è una storia di una speranza e di una lotta per una vita diversa; è una storia di corse automobilistiche e di un dramma familiare, raccontata con misura, a tratti commovente, storia di un ricongiungimento tra anime perse.
Giulia De Martino è una diciassettenne che partecipa, spronata dal padre, al campionato italiano GT. Purtroppo durante una gara il padre di Giulia muore a causa di un infarto e al funerale compare Loris, il fratello maggiore, che si era allontanato dalla famiglia perché oramai tossicodipendente. Loris è un ex-pilota, soprannominato “ballerino” e pur di non perdere la casa, ereditata dal padre, comincia a fare da trainer a Giulia. Nel rapporto sempre più stretto che si instaura tra maestro e allieva, tra fratello maggiore e sorella minore, c’è soprattutto l’invito ad assumersi quei rischi necessari per emergere e a costo di tagliare il cordolo anche se la curva è pericolosa, perché solo ai temerari è destinata la vittoria.
Lei, piena di grinta e più matura della sua età, e lui, che ha sperperato il suo talento con le droghe pesanti, non potrebbero essere più distanti, ma trovano un terreno comune in quella passione per l’alta velocità che è nel DNA di famiglia.
Veloce come il vento, ispirato alla storia del pilota Carlo Capone, star delle corse negli anni ’80 oggi in cura per gravi problemi psichiatrici è anche molto altro: ha a riferimento i modelli hollywoodiani di genere, riadattati però con misura a contesti e contenuti prettamente italiani, ha la spettacolarità carica d’adrenalina delle corse, in pista come per strada; la storia del riscatto perlomeno parziale di Loris, inclusi gli accenni agli aspetti più drammatici della droga, esaspera lo scontro tra responsabilità e irresponsabilità, tra rischio e controllo.
Ottima la scelta dei protagonisti, con da un lato la giovane esordiente Matilda De Angelis, personaggio femminile raccontato in un contesto tipicamente maschile, capace di dare il giusto carattere a Giulia; dall’altra quella di uno Stefano Accorsi perfetto nel ruolo di tossico e disperato, fratello dimenticato, ma progressivamente sempre più interessato a far funzionare le cose per opportunismo ma anche per un affetto che progressivamente scopre.
Il film di Rovere appassiona e coinvolge e non annoia, imperfetto ma vero, coraggioso, assolutamente e finalmente innovativo per il cinema italiano; un motor movie all’emiliana, con tanto di slang romagnolo, di corse e di scontri, di sorpassi e di frenate, di curve tagliate e di cordoli, sui circuiti di Monza, Imola e Vallelunga e sulle strade cittadine di Matera, con al volante piloti sprezzanti del pericolo e disperati, che si giocano il tutto per tutto per superare i propri limiti e sopravvivere.
data di pubblicazione: 8/4/2016
Scopri con un click il nostro voto: 

da Rossano Giuppa | Apr 6, 2016
(Teatro Argentina – Roma, 30 marzo/10 aprile 2016)
Preamleto, ovvero il dramma prima del dramma.
Il vecchio Re Amleto ha l’alzheimer. Non ricorda niente, né sua moglie Gertrude, né il figlio Amleto e il fratello Claudio. Non ha ricordi ma ha ancora il potere, è vivo, siede in poltrona, da solo, in un bunker di cemento armato. Quel grigio e solido contenitore lo protegge da nemici e dagli occhi impietosi di chi non lo rispetterebbe più come capo.
Intorno a lui, nel giorno del suo compleanno, si compone il quadretto familiare: il fratello Claudio, avido di potere ma incapace di spodestare l’anziano capo; la moglie Gertrude, donna complessa, non materna, amante del cognato, dilaniata dal desiderio del comando e insofferente al ruolo di badante del marito; il consigliere del Re, Polonio, indeciso, comico e viscido al tempo stesso; e infine il giovane e impulsivo Amleto, che pensa di essere in grado di difendere la memoria e l’onore del padre, incentrando su di sé il comando.
Peccato che predomini su tutti l’incapacità… di essere madre di Gertrude, di essere in grado di governare di Claudio, di vendicare il padre da parte di Amleto, di essere fedele da parte di Polonio. Gruppo di famiglia in un interno. Solo il vecchio re, sereno e distaccato grazie alla malattia, riesce a fornire la chiave per sfuggire alla materialità ed alla schiavitù del potere.
Intrecci e motivazioni che nel testo shakespeariano sono lasciati alla libera fantasia dello spettatore trovano qui un prologo riflessivo e spiazzante. Se cambiassero i presupposti, la vicenda di Amleto sarebbe la tragedia annunciata? E quali sono le reazioni che si innestano nello stretto gruppo familiare costretto a confrontarsi con il potere?
“Il potere a questo serve: a continuare a comandare” dice Gertrude al Re per convincerlo a prendere l’unica decisione che le pare giusta.
Michele Santeramo scrive un testo che, se da un lato racconta l’antefatto della tragedia, prima della morte del re Amleto padre, prima che diventi lo spirito inquieto e lugubre che si aggira sulle torri del castello di Elsinore, dall’altro proietta storia e personaggi della tragedia shakespeariana in una realtà contemporanea, in un claustrofobico rifugio di cemento armato in cui il Re, seppur malato, è più libero e meno terreno di tutti.
Potere, egoismi, lussuria, soprusi, in un contesto nel quale la vita e la morte si invertono, vero e falso si mescolano. Il vecchio Re suggerisce allora una via d’uscita alla spirale di violenza a cui i personaggi sembrano destinati invitando saggiamente moglie e fratello a inscenare la sua morte e a far credere al figlio che sia stato vittima di un vile omicidio; si mostrerà poi al giovane Amleto come fosse un fantasma con Claudio, Gertrude e Polonio che reggeranno il gioco e fingeranno di non vederlo. Il figlio convinto di delirare e in preda ai sensi di colpa abbandona ogni velleità di comando e Claudio e Gertrude saranno i nuovi capi obbligati alla «peggiore delle condanne: ovvero vivere comandando» mentre Amleto potrà «buttar via la parte peggiore di sé e vivere più puro con l’altra metà» non vendicando la morte del padre.
Uno spettacolo intelligente e profondo quello proposto dalla regista Veronica Cruciani in scena al Teatro Argentina dal 30 marzo al 10 aprile 2016 e poi ancora in tournée in Italia.
Un cast convincente guidato dagli eccellenti Massimo Foschi (Re Amleto) e Manuela Mandracchia (Gertrude), in cui molto incisivi risultano anche Michele Sinisi (Claudio), Gianni D’Addario (Polonio) e Matteo Sintucci (Amleto figlio).
Le scelte registiche si rivelano efficaci nel confezionare una pièce equilibrata in ogni suo aspetto, dalle scene ai costumi, alle luci ed alla musica, nella quale spiccano sicuramente la forza e la immediatezza dei messaggi, la contemporaneità dei personaggi, il confronto tra la materialità e la schiavitù del potere e la leggerezza e la purezza del distacco.
data di pubblicazione: 06/04/2016
Il nostro voto: 

da Rossano Giuppa | Mar 13, 2016
(Teatro Eliseo – Roma, 8/20 marzo 2016 e in tournée)
Carlo Cecchi porta in scena dall’8 al 20 marzo al Teatro Eliseo di Roma La dodicesima notte, la commedia per eccellenza di Shakespeare, in una produzione Marche Teatro Stabile in collaborazione con Estate Teatrale Veronese, in tournée in Italia fino alla fine di aprile 2016.
La commedia degli equivoci e degli scambi di ruolo, in un mix perfetto di intrecci e colpi di scena, una giostra in continuo movimento in cui si alternano personaggi variopinti e connotati, rappresentanti di uno spaccato del genere umano senza tempo ma assolutamente attuale. Un adattamento dinamico e leggero, grazie anche alla traduzione di Patrizia Cavalli, che rende il testo seicentesco decisamente contemporaneo, senza stravolgerlo nell’essenza.
Carlo Cecchi ha curato una regia equilibrata e composta. L’amore è il tema della commedia; la musica, che, come dice il Duca nei primi versi “è il cibo dell’amore”, ha una funzione determinante. Non come commento ma come azione. La scena reinventa un espace de jeu che permette, senza nessuna pretesa realistica o illustrativa, il susseguirsi rapido e leggero di questa strana malinconica commedia, perfetta fino al punto, a volte, di rasentare la farsa (Carlo Cecchi).
Trama ricca di intrecci: tutto si svolge nell’Illiria, un territorio indefinito dove Shakespeare fa approdare i suoi protagonisti scampati a un naufragio. La giovane Viola, sopravvissuta ad esso, travestita da paggio si pone a servizio del Duca Orsino e si innamora di lui. Questi spasima per la nobildonna Olivia e le manda messaggi passionali per mezzo di Viola-Cesario. Disgraziatamente la Contessa si innamorerà proprio di Cesario e Viola si ritroverà così al centro di un bizzarro triangolo amoroso. Un inaspettato colpo di scena fa poi arrivare in Illiria il fratello gemello di Viola, Sebastiano, in realtà anche lui sopravvissuto al naufragio; i due fratelli si ricongiungono e Viola potrà finalmente confessare il suo amore al Duca mentre la Contessa vivrà felice insieme a Sebastiano. Ma in mezzo c’è dell’altro. C’è Malvoglio, il maggiordomo di Olivia, pieno di boria e di malinconia, innamorato della padrona, bersaglio di un atroce scherzo. Alla trama principale è infatti affiancata, come spesso accade in Shakespeare, una sottotrama ricchissima di episodi, quasi più estesa della prima. E Carlo Cecchi, come egli stesso spiega nelle note di regia, decide volutamente di conferire maggiore importanza a tale sottotrama, che considera addirittura più importante e interessante del filone principale. Il concentrarsi maggiormente sul vero nucleo comico della vicenda costituisce l’elemento innovativo dello spettacolo, in grado mettere in scena un vero e proprio carnevale, animato da personaggi allegorici e realistici al tempo stesso.
Un cast allegro e accattivante di bravi attori formato da Daniela Piperno, Vincenzo Ferrera, Loris Fabiani, Giuliano Scarpinato e Dario Lubatti. Ottima anche l’interpretazione di Barbara Ronchi nel personaggio di Olivia, involontaria partecipante delle follie del bizzarro ménage familiare. Ma grande mattatore in scena è proprio Carlo Cecchi, interprete del maggiordomo di Olivia, Malvolio, pomposo e austero, vittima di una beffa feroce che lo fa credere oggetto di attenzioni da parte della sua signora, spingendolo a rendersi pubblicamente ridicolo con indosso calze gialle e giarrettiere a croce per far colpo sulla donna.
L’allestimento scenico è essenziale e rarefatto ma non spoglio, grazie a una pedana girevole centrale che dà continuo dinamismo. Splendidi i costumi di Nanà Cecchi eleganti e divertenti, e di grande effetto la musica dal vivo composta da Nicola Piovani in grado di rendere l’atmosfera magicamente onirica e vivace.
data di pubblicazione:13/03/2016
Il nostro voto: 

da Rossano Giuppa | Feb 13, 2016
(Teatro Argentina – Roma, 2/14 febbraio 2016)
Un vecchio cinema, una fila di sedie di legno ed una donna che percorre a lunghi passi, per tutta la sua lunghezza, il palcoscenico chiedendo aiuto, mentre alle sue spalle le poltrone vengono a poco a poco popolate da scimmioni albini, che hanno a loro volta alle spalle uno schermo che proietta immagini ombre di Fassbinder e di Sybille Schmitz.
Un inizio straziante e dissonante: la voce dell’attrice contrapposta al coro ritmico e marziale di scimmioni che poi, spogliandosi a poco a poco della loro veste bestiale e rimanendo letteralmente in mutande si trasformeranno in tanti altri personaggi dell’universo fassinderiano.
Latella reincontra un regista che gli è caro, cioè quel Fassbinder da cui già era nato, nel 2006, Le lacrime amare di Petra von Kant e mette in scena Veronika Voss, protagonista del film omonimo, in Ti regalo la mia morte, Veronika: e lo fa cercando una fedeltà che coniughi le caratteristiche estetiche e narrative del film alla sua personale e potente visione teatrale.
Ci troviamo di fronte ad un teatro complesso, austero, difficile, che richiede massima concentrazione, ma raffinato e simbolico.
Veronika Voss è il personaggio che Fassbinder creò ispirandosi a Sybille Schmitz, attrice tedesca molto nota ai tempi del Terzo Reich.
Con le luci di sala ancora accese, Veronika si presenta con il corpo e la voce di Monica Piseddu, con addosso solo un vestito sgualcito e una giacca rossa.
Un inizio pirandelliano dai diversi piani narrativi per una storia costruita da Rainer Werner Fassbinder attorno a un’attrice famosa negli anni Trenta, stella cinematografica del Reich, caduta in disgrazia dopo la caduta del potere hitleriano.
Comincia così la discesa allucinata nel suo passato, da cui emergono immagini di dolore e vergogna, come il suo legame con Goebbels e con il credo nazista.
Gli scimmioni sono il coro di una storia che viene a sua volta ripresa da una macchina che percorre anch’essa per tutta la lunghezza il palcoscenico avanti e indietro e che idealmente la trasmette e ne immortala i fotogrammi.
Voce fuori campo Robert Krohn, che come nel film di Fassbinder è un giornalista sportivo che si presenta al pubblico con le sue telecronache delle corse di cavalli e che è innamorato dall’ex diva: cerca di salvarla dal progressivo abbandono alla morfina, che le viene somministrata in dosi abbondanti da una clinica compiacente e da una neurologa intenzionata ad arricchirsi grazie alla sua dipendenza; vorrebbe salvarla sostenendola nel momento in cui viene scritturata per una piccola parte che potrebbe essere per lei una rinascita e, invece, è un fallimento, la sua fine definitiva.
Un viaggio nella mente devastata di Veronika, diva sul viale del tramonto, dove i ricordi e i personaggi rievocati diventano immagini sfocate in bianco e nero.
Un percorso che però ci instrada anche verso le altre donne del cinema fassbinderiano (Maria Braun, Martha, Emma Küsters, la trans Elvira di Un anno con tredici lune), alla fine riunite in un paradiso pagano, in un giardino in cui troneggia un ciliegio calato dall’alto un mondo parallelo a metà tra le atmosfere di Cechov e la “Colazione sull’erba” di Manet.
Spettacolo non semplice ma affascinante, in scena al Teatro Argentina di Roma dal 2 al 14 febbraio, Ti regalo la mia morte Veronika è interpretato da un gruppo affiatato di attori (Valentina Acca, Candida Nieri, Caterina Carpio, Nicole Kehrberger, Fabio Pasquini, Maurizio Rippa) mentre Massimo Albarello, Sebastiano Di Bella, Fabio Belillo sono le ombre. Veronika Voss come già detto, è interpretata da una bravissima Monica Piseddu, mentre Annibale Pavone è Robert, l’unico uomo al quale è permesso, dopo la morte, di entrare nel magico giardino dei ciliegi e dei passi perduti.
Difficile, complesso, volutamente intricato, visionario.
data di pubblicazione:13/02/2016
Il nostro voto: 



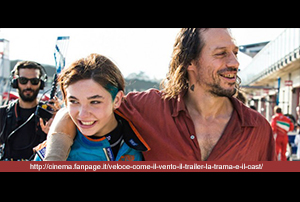









Gli ultimi commenti…